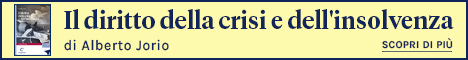
Articoli Correlati: comparative corporate governance - riflessioni - seconda edizione - the anatomy of corporate law
1. Introduzione. - 2. La struttura del libro. - 3. Conclusioni. - NOTE
“Il libro del decennio”. Così, enfaticamente nella sua recensione, David Skeel jr. [1] presentava la Prima Edizione del libro. E se il valore di un prodotto si misura in termini di successo di vendite, non c’è dubbio che «The Anatomy of Corporate Law» rappresenti un fenomeno giuridico-letterario ineguagliabile. La Prima Edizione si è, infatti, ben presto imposta sul mercato globale come punto di riferimento imprescindibile per tutti coloro che si occupano di diritto societario comparato o, meglio ancora, di “corporate governance” comparata. Il perché è presto spiegato: essa forniva in poco più di duecento pagine una visione sinottica ed esaustiva del diritto societario nei vari ordinamenti presi in considerazione (USA, Regno Unito, Francia, Germania e Giappone), adottando una metodologia d’analisi innovativa e, per così dire, “user-friendly”. Gli originari promotori (Reinier Kraakman dell’Università di Harvard, Paul Davies della London School of Economics, Henry Hansmann della New York University – ora a Yale – Gérard Hertig dell’ETH di Zurigo, Klaus J. Hopt del Max-Planck-Institut di Amburgo, Hideki Kanda dell’Università di Tokyo, Edward B. Rock dell’Università della Pennsylvania), nella Seconda Edizione, hanno deciso di ampliare la compagine degli autori a due nuovi ingressi (John Armour dell’Università di Oxford e Luca Enriques dell’Università di Bologna, portando così a nove il numero complessivo dei contributori) e, dopo tre anni di ulteriori revisioni, hanno altresì ritenuto opportuno rivisitare la propria opera per oltre il 70% fino ad aggiungere ben 90 pagine, passando dalle precedenti 226 alle attuali 315 [2]. Dal punto di vista strettamente contenutistico, invece il cambiamento non attiene tanto all’architrave portante del libro, quanto piuttosto ad aspetti complementari che cinque anni di dibattito intercontinentale non avevano mancato di sottolineare. Il principio ispiratore del libro – ed il “fil rouge” che lega tutti i suoi capitoli – risiede nella convinzione che il diritto societario, inteso come il diritto delle società di capitali, o meglio, delle società per azioni aperte, possa essere spiegato come quell’insieme di norme (definite “strategie [continua ..]
La struttura del libro procede sulla falsariga di un modello economico: alla Prefazione, che descrive i tratti caratterizzanti dell’indagine, seguono i primi due, fondamentali, Capitoli, che individuano i confini dell’analisi ed il metodo adottato. I Capitoli da 3 a 9 applicano il modello ad una serie di operazioni che si compiono tipicamente durante la vita delle società di capitali. L’ultimo Capitolo esamina i risultati ottenuti. – Nella breve Prefazione (tre sole pagine) la metodologia impiegata viene definita «international», «functional», «neutral», «short». Internazionale, sia perché gli autori provengono da esperienze nazionali diverse sia perché l’approccio adottato è quello comparatistico: l’analisi viene difatti svolta guardando contemporaneamente alle soluzioni accolte nei vari ordinamenti presi in considerazione, nella convinzione che «almeno ad un livello intermedio di astrazione, i problemi posti e le soluzioni offerte sono comuni ed indipendenti dalle leggi concretamente esistenti nei singoli ordinamenti». Funzionale, dal momento che mira ad evidenziare la logica economica alla base del diritto societario, pur riconoscendo che assetti proprietari, scelte politiche e fattori extralegali riconducibili al concetto di “path dependence” hanno una loro influenza non marginale nella scelta delle norme di diritto societario. Neutrale, perché l’obiettivo dell’opera consiste nel proporre l’innovativo metodo investigativo piuttosto che nel procedere a valutazioni assiologiche sui vari ordinamenti che anzi vengono esplicitamente escluse dal campo di indagine. Breve, infine, perché riesce a compendiare l’analisi in poco più di trecento pagine. Nella Seconda Edizione la Prefazione comprende, poi, anche una rapida indicazione dei principali cambiamenti avvenuti rispetto alla Prima: l’inclusione dei due nuovi autori summenzionati (e, di conseguenza, l’inclusione nell’esame anche dell’Italia); le modifiche necessarie per dar conto delle recenti riforme negli ordinamenti presi in considerazione; la maggiore attenzione riservata agli studi empirici nel quadro del diritto societario; l’inserimento nell’ambito dell’analisi sia del diritto fallimentare sia del momento dell’“enforcement ” (due argomenti [continua ..]
La compattezza e la brevità del volume, la moderna ed aggiornata visione del diritto societario comparato, il riferimento ai più recenti studi empirici e – con un pizzico di campanilismo – l’inclusione dell’Italia tra gli ordinamenti presi in considerazione rendono l’opera un prodotto fortemente competitivo nella letteratura giuridica (e giuseconomica) contemporanea. Il vero punto di forza del libro, però, consiste sicuramente nel carattere innovativo della metodologia adottata: il tentativo di proporre un lessico comune ed una prospettiva funzionale attraverso cui comparare il diritto di vari Stati è un esperimento che va certamente apprezzato perché presenta l’indubbio vantaggio di offrire un veicolo logico-linguistico mediante il quale esperienze ed idee diverse possono essere agevolmente comunicate, permettendo in tal modo il confronto e l’arricchimento reciproco. Non va poi dimenticato che si tratta di un libro collettivo: a tal proposito, preme però evidenziare che, nonostante la pluralità degli interventi, anche grazie alla uniformità metodologica, condivisa dai vari Autori, soltanto occasionalmente è percepibile una eterogeneità di stili che menoma la scorrevolezza. Piuttosto, il confronto reciproco e, in breve, la “cross fertilization” garantiscono risultati attendibili proprio in quanto abbondantemente, e collegialmente, meditati. Tuttavia, si segnalano alcuni profili problematici che il libro pare chiarire solo in parte. In primo luogo, come è stato notato, essendo l’indagine limitata alle sole società per azioni, non viene del tutto esplicitato il motivo per cui si adotti tale tipologia societaria, quasi che si tratti di una variabile esogena al modello [14]. D’altra parte, lo sforzo di prospettare un “pansocietarismo” mondiale come chiave delle iniziative economiche di una certa dimensione va forse rivisitato, ancor più alla luce dell’attuale contesto storico nel quale si assiste ad un ricorso progressivamente maggiore a strumenti alternativi rispetto alle società per azioni (si pensi ad esempio alle alternative business entities statunitensi o alle società a responsabilità limitata – S.r.l., GmbH, S.a.r.l. – europee). In secondo luogo, come gli Autori opportunamente precisano, l’approccio funzionalista regge allorché [continua ..]