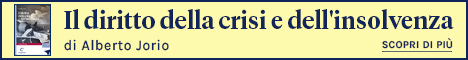
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, Sezione I, 11 maggio 2006 (causa c-340/04) – Jann Presidente – Rodrigues Relatore – Carbotermo s.p.a. e Consorzio Alisei (Avv.ti B. Becchi e L. Grillo) c. Comune di Busto Arsizio (Avv. C. Caputo) e AGESP s.p.a. (Avv.ti A. Sciumé e D. Tassan Mazzocco)
Appalto di fornitura e servizi – Affidamento diretto ad una s.p.a. – Presupposti – Insussistenza.
(Dir. 93/36/Cee; Dir. 92/50/Cee)
La disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici osta all’affidamento diretto di un appalto di forniture e di servizi (con prevalenza del valore della fornitura) a una società per azioni il cui consiglio di amministrazione possiede ampi poteri di gestione esercitabili in maniera autonoma e il cui capitale è interamente detenuto da un’altra società per azioni, della quale è a sua volta socio di maggioranza l’amministrazione aggiudicatrice. (1)
Per valutare se la società beneficiaria di un affidamento diretto svolga la parte più importante della sua attività con l’ente o con gli enti pubblici che ne detengono il capitale occorre avere riguardo a tutte le attività realizzate da tale società in esecuzione dell’affidamento o degli affidamenti ricevuti, indipendentemente dal soggetto che provvede a remunerare dette attività e dal territorio in cui queste ultime sono svolte. (2)
(Omissis) – La controversia di cui alla causa principale e le questioni pregiudiziali
8 La Carbotermo è un’impresa specializzata negli appalti di fornitura di energia e di gestione di impianti termici, a favore di clienti pubblici e privati.
9 Il consorzio Alisei è un’impresa che fornisce prodotti energetici e servizi attinenti alla climatizzazione e al riscaldamento degli edifici.
10 La AGESP Holding SpA (in prosieguo: la “AGESP Holding”) è una società per azioni nata dalla trasformazione, decretata il 24 settembre 1997, dell’Azienda per la Gestione dei Servizi Pubblici, impresa speciale del comune di Busto Arsizio. Il capitale sociale della AGESP Holding appartiene attualmente per il 99,98% al comune di Busto Arsizio. Gli altri azionisti sono i comuni di Castellanza, Dairago, Fagnano Olona, Gorla Minore, Marnate e Olgiate Olona, ciascuno dei quali detiene un’azione.
11 Ai sensi dell’art. 2 del suo statuto, nell’oggetto della AGESP Holding rientra la gestione di servizi di pubblica utilità nei settori del gas, dell’acqua, dell’igiene ambientale, dei trasporti, dei parcheggi, dei bagni pubblici, delle farmacie, dell’energia elettrica e del calore, dei servizi cimiteriali e della segnaletica stradale.
12 L’art. 6 del suddetto statuto prevede che:
“(…) [L]a maggioranza delle azioni [è] riservata al Comune di Busto Arsizio.
(…)
Oltre al Comune di Busto Arsizio possono entrare a far parte della Società altri enti pubblici territoriali locali (Province, Comuni e loro consorzi), enti economici, finanziari, associazioni territoriali e di categoria, nonché privati cittadini che ne condividano le finalità statutarie (…)”.
13 L’art. 7 dello stesso statuto precisa quanto segue:
“Nessun socio privato può possedere una quota superiore alla decima parte dell’intero capitale della società (…)”.
14 Ai sensi dell’art. 18 dello statuto della AGESP Holding, quest’ultima è amministrata da un consiglio di amministrazione.
15 A norma dell’art. 26 del suddetto statuto:
“Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi solo quelli che la Legge o lo Statuto in modo tassativo riservano all’Assemblea (…)”.
16 La AGESP è una società per azioni costituita il 12 luglio 2000 dalla AGESP Holding e il cui capitale sociale appartiene attualmente per il 100% a quest’ultima.
17 A norma dell’art. 3 del suo statuto, nella versione modificata – prodotta dinanzi al giudice a quo – con la quale è stato ampliato l’oggetto della società, la AGESP ha per oggetto l’esercizio di attività connesse ai servizi di pubblica utilità nei settori del gas, dell’acqua, dell’igiene ambientale, dei trasporti, dei parcheggi, dell’energia elettrica, del calore, della climatizzazione, dell’informatica, delle telecomunicazioni, della gestione del sottosuolo, dell’illuminazione nonché la prestazione di altri servizi in favore delle società associate.
18 L’art. 7 dello statuto della AGESP così prevede:
“Nessun socio, ad eccezione della Società controllante AGESP Holding (…), può possedere una quota superiore alla decima parte dell’intero capitale della società (…)”.
19 Ai sensi dell’art. 17 del suddetto statuto, la AGESP è amministrata da un consiglio.
20 A questo proposito, l’art. 19 dello stesso statuto precisa quanto segue:
“Al Consiglio competono [i] più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società (…)”.
21 Il 22 settembre 2003 il comune di Busto Arsizio ha indetto una gara per la fornitura di combustibili, nonché per la manutenzione, l’adeguamento normativo e la riqualificazione tecnologica degli impianti termici degli edifici comunali. L’importo dell’appalto, stimato nella misura di EUR 8 450 000 oltre all’imposta sul valore aggiunto (IVA), era ripartito in EUR 5 700 000 per la fornitura di combustibili (di cui gasolio per 4/5 e metano per 1/5), EUR 1 000 000 per la manutenzione degli impianti termici ed EUR 1 750 000 per la riqualificazione e la messa a norma dei suddetti impianti.
22 La Carbotermo ha presentato un’offerta in data 22 novembre 2003. Il consorzio Alisei ha predisposto un’offerta senza tuttavia presentarla entro il termine previsto.
23 Il 21 novembre 2003 il comune di Busto Arsizio ha deciso, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 5316, menzionata al punto 7 della presente sentenza, di sospendere la procedura di gara fino al 10 dicembre 2003.
24 Con deliberazione 10 dicembre 2003, il comune di Busto Arsizio ha revocato la gara, riservandosi di affidare in seguito l’appalto direttamente alla AGESP.
25 Con deliberazione 18 dicembre 2003, il comune di Busto Arsizio ha affidato l’appalto in questione direttamente alla AGESP. Esso ha motivato tale decisione adducendo che la AGESP soddisfaceva i due requisiti stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per concludere appalti pubblici senza gara, vale a dire che l’ente locale eserciti sull’ente aggiudicatario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e che il suddetto ente aggiudicatario realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente locale che lo controlla. Nel preambolo di tale decisione si afferma, da un lato, che il fatto che il comune di Busto Arsizio detenga il 99,98% del capitale della AGESP Holding, alla quale appartiene per il 100% il capitale della AGESP, attesta un rapporto di subordinazione tra quest’ultima e il comune in questione. D’altro lato, in detto preambolo si afferma che la parte largamente maggioritaria del fatturato della AGESP consegue dall’esercizio di attività per le quali la stessa è titolata in forza di affidamenti ottenuti direttamente dal comune di Busto Arsizio.
26 Con bando del 23 gennaio 2004, la AGESP ha indetto una gara d’appalto nell’ambito di una procedura accelerata per la fornitura del gasolio in questione e in data 27 febbraio 2004 ha affidato il suddetto appalto all’impresa Pezzoli Petroli Srl. In date 28 aprile, 18 maggio, 30 giugno e 2 settembre 2004, la AGESP ha affidato ad altre imprese appalti riguardanti il passaggio al metano, la riqualificazione tecnologica, l’adeguamento normativo e l’installazione di un sistema di controllo e di gestione a distanza per gli impianti termici di vari edifici comunali. Né la Carbotermo né il consorzio Alisei risultavano tra le imprese aggiudicatarie di questi appalti.
27 La Carbotermo e il consorzio Alisei hanno impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia le deliberazioni che avevano sospeso la gara e affidato l’appalto in questione alla AGESP.
28 Dinanzi al summenzionato tribunale le due imprese in questione hanno rilevato che, nel caso di specie, non ricorrevano le condizioni che rendono inapplicabile la direttiva 93/36. Da un lato, la AGESP non sarebbe controllata dal comune di Busto Arsizio in quanto quest’ultimo detiene la sua partecipazione nella AGESP solo mediante una holding di cui è azionista per il 99,98% e la AGESP conserva l’autonomia di una società per azioni di diritto privato. Dall’altro lato, la AGESP non svolgerebbe la parte più importante della sua attività a favore del comune di Busto Arsizio, poiché realizzerebbe con il comune in questione una quota nettamente inferiore all’80% del suo fatturato, criterio che si sarebbe dovuto accogliere per analogia con l’art. 13 della direttiva 93/38.
29 Il comune di Busto Arsizio e la AGESP hanno replicato che l’affidamento diretto era consentito nella fattispecie poiché la AGESP era controllata dal comune di Busto Arsizio in ragione della partecipazione di quest’ultimo al suo capitale e che la stessa svolgeva la parte più importante della sua attività con il suddetto comune. A tale proposito, la AGESP ha precisato che oltre il 28% del fatturato da essa realizzato nel territorio del comune di Busto Arsizio si riferiva a prestazioni direttamente fornite al comune e che il fatturato da essa realizzato nel suddetto territorio rappresentava il 65,59% del suo fatturato globale.
30 Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
“1) se sia compatibile con la direttiva 93/36 (...) l’affidamento diretto dell’appalto per la fornitura di combustibili e calore per impianti termici di edifici di proprietà o competenza del Comune, e relativa gestione, conduzione, manutenzione (con prevalenza del valore della fornitura), ad una società per azioni il cui capitale è, allo stato attuale, interamente detenuto da un’altra società per azioni, della quale è a sua volta socio di maggioranza (al 99,98%) il Comune appaltante, ovvero ad una società (AGESP) che non è partecipata direttamente dall’Ente Pubblico, ma da un’altra società (AGESP Holding) il cui capitale è attualmente posseduto al 99,98% dalla Pubblica Amministrazione;
2) se il requisito dello svolgimento, da parte dell’impresa alla quale è stata direttamente affidata la fornitura, della parte più importante dell’attività con l’Ente pubblico che la controlla debba essere accertato facendo applicazione dell’art. 13 della direttiva 93/38 (…), e possa ritenersi sussistente nel caso in cui la suddetta impresa realizzi la prevalenza dei proventi con l’Ente pubblico controllante o, in alternativa, nel territorio dell’Ente stesso”.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
31 La Corte ha già statuito che, se un appalto pubblico ha ad oggetto nel contempo prodotti ai sensi della direttiva 93/36 e servizi ai sensi della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), esso rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 93/36 qualora il valore dei prodotti oggetto dell’appalto sia superiore a quello dei servizi (sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal, Racc. pag. I-8121, punto 38). Un appalto come quello di cui trattasi nella causa principale, in cui il valore dei prodotti è superiore a quello dei servizi oggetto dello stesso, rientra pertanto nell’ambito di applicazione della direttiva 93/36, come ha d’altronde constatato il giudice del rinvio.
32 L’esistenza di un contratto ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 93/36 implica che vi sia stato un incontro di volontà tra due persone distinte (sentenza Teckal, cit., punto 49).
33 Conformemente all’art. 1, lett. a), della suddetta direttiva, basta, in linea di principio, che il contratto sia stato stipulato tra, da una parte, un ente locale e, dall’altra, una persona giuridicamente distinta da quest’ultimo. Può avvenire diversamente solo nel caso in cui, nel contempo, l’ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la detengono (sentenza Teckal, cit., punto 50).
34 Dall’ordinanza di rinvio e dagli atti di causa risulta che, allo stato, all’amministrazione aggiudicatrice appartiene il 99,98% del capitale della AGESP Holding, mentre il restante 0,02% è nelle mani di altri enti locali. Conformemente allo statuto della AGESP Holding, azionisti privati possono entrare nel capitale di tale società a due condizioni: da un lato, la maggioranza delle azioni è riservata al comune di Busto Arsizio; dall’altro, nessun azionista privato può possedere una quota superiore alla decima parte del capitale della suddetta società.
35 A sua volta, la AGESP Holding detiene, allo stato, il 100% del capitale della AGESP. In base allo statuto di quest’ultima, il suo capitale può essere accessibile ad azionisti privati alla sola condizione che a nessun azionista, ad eccezione della AGESP Holding, possa appartenere più di un decimo del capitale della suddetta società.
36 Per valutare se l’amministrazione aggiudicatrice eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è necessario tener conto di tutte le disposizioni normative e delle circostanze pertinenti. Da quest’esame deve risultare che la società aggiudicataria è soggetta a un controllo che consente all’amministrazione aggiudicatrice di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società (v. sentenza 13 ottobre 2005, causa C-458/03, Parking Brixen, Racc. pag. I‑8585, punto 65).
37 Il fatto che l’amministrazione aggiudicatrice detenga, da sola o insieme ad altri enti pubblici, l’intero capitale di una società aggiudicataria potrebbe indicare, pur non essendo decisivo, che l’amministrazione aggiudicatrice in questione esercita su detta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi del punto 50 della menzionata sentenza Teckal.
38 Degli atti di causa risulta che gli statuti della AGESP Holding e della AGESP attribuiscono al consiglio di amministrazione di ciascuna delle società i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Gli statuti di cui trattasi non riservano al comune di Busto Arsizio nessun potere di controllo o diritto di voto particolare per limitare la libertà d’azione riconosciuta a detti consigli di amministrazione. Il controllo esercitato dal comune di Busto Arsizio su queste due società si risolve sostanzialmente nei poteri che il diritto societario riconosce alla maggioranza dei soci, la qual cosa limita considerevolmente il suo potere di influire sulle decisioni delle società di cui trattasi.
39 Inoltre, l’eventuale influenza del comune di Busto Arsizio sulle decisioni della AGESP viene esercitata mediante una società holding. L’intervento di un siffatto tramite può, a seconda delle circostanze del caso specifico, indebolire il controllo eventualmente esercitato dall’amministrazione aggiudicatrice su una società per azioni in forza della mera partecipazione al suo capitale.
40 Ne consegue che, in tali circostanze, previa verifica di queste ultime da parte del giudice di merito di cui alla causa principale, l’amministrazione aggiudicatrice non esercita sulla società aggiudicataria dell’appalto pubblico in questione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
41 L’art. 6 della direttiva 93/36 impone alle amministrazioni che aggiudicano un appalto pubblico di ricorrere alla procedura aperta o alla procedura ristretta, salvo che l’appalto rientri in uno dei casi eccezionali tassativamente elencati ai nn. 2 e 3 del suddetto articolo. Dall’ordinanza di rinvio non risulta che l’appalto di cui trattasi nella causa principale rientri in uno di tali casi.
42 Ne consegue che la direttiva 93/36 osta all’affidamento diretto di un appalto pubblico in circostanze analoghe a quelle della causa principale.
43 Contro una conclusione in tal senso il governo italiano obietta che il fatto che la AGESP debba ricorrere a una procedura di aggiudicazione pubblica per acquistare il gasolio in questione prova che il comune di Busto Arsizio, la AGESP Holding e la AGESP devono essere considerati nel loro insieme come un unico “organismo di diritto pubblico” ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva 93/36, tenuto ad aggiudicare appalti pubblici di forniture in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia.
44 Tale argomento non può essere accolto. Da un lato, il comune di Busto Arsizio rientra nella nozione di “ente locale” e non in quella di “organismo di diritto pubblico” ai sensi di detta disposizione. D’altro lato, il comune di Busto Arsizio, la AGESP Holding e la AGESP dispongono ciascuno di una distinta personalità giuridica.
45 Peraltro, come ha rammentato la Corte al punto 43 della menzionata sentenza Teckal, le sole deroghe consentite all’applicazione della direttiva 93/36 sono quelle in essa tassativamente ed espressamente menzionate.
46 Ora, la direttiva 93/36 non contiene alcuna disposizione analoga all’art. 6 della direttiva 92/50, che escluda dal suo ambito di applicazione appalti pubblici aggiudicati, a talune condizioni, ad amministrazioni aggiudicatrici (sentenza Teckal, cit., punto 44).
47 Si deve di conseguenza risolvere la prima questione nel senso che la direttiva 93/36 osta all’affidamento diretto di un appalto di forniture e di servizi, con prevalenza del valore della fornitura, a una società per azioni il cui consiglio di amministrazione possiede ampi poteri di gestione esercitabili in maniera autonoma e il cui capitale è, allo stato attuale, interamente detenuto da un’altra società per azioni, della quale è a sua volta socio di maggioranza l’amministrazione aggiudicatrice.
Sulla seconda questione
48 La seconda questione consta di due parti.
49 Da un lato, il giudice del rinvio intende chiarire se la condizione consistente nello svolgimento, da parte dell’impresa alla quale è stata direttamente affidata la fornitura, della parte più importante dell’attività con l’ente pubblico che la detiene debba essere accertata facendo applicazione dell’art. 13 della direttiva 93/38. D’altro lato, esso si chiede se si possa ritenere che tale presupposto ricorra nel caso in cui la suddetta impresa realizzi la prevalenza dei proventi con l’ente pubblico che la detiene o nel territorio dell’ente stesso.
Prima parte della seconda questione
(Omissis)
Seconda parte della seconda questione
58 Si deve rammentare che l’obiettivo principale delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici è la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché l’apertura ad una concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle e RPL Lochau, Racc. pag. I-1, punto 44).
59 Le condizioni in presenza delle quali, secondo la menzionata sentenza Teckal, la direttiva 93/36 è inapplicabile agli appalti conclusi tra un ente locale e un soggetto giuridicamente distinto da quest’ultimo, vale a dire che, al contempo, l’ente locale eserciti sul soggetto in questione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che il soggetto di cui trattasi svolga la parte più importante della sua attività con l’ente o gli enti locali che lo detengono, hanno, in particolare, lo scopo di evitare che sia falsato il gioco della concorrenza.
60 La condizione che il soggetto di cui trattasi realizzi la parte più importante della sua attività con l’ente o gli enti locali che lo detengono è finalizzata, in particolare, a garantire che la direttiva 93/36 continui ad essere applicabile nel caso in cui un’impresa controllata da uno o più enti sia attiva sul mercato e possa pertanto entrare in concorrenza con altre imprese.
61 Infatti, un’impresa non è necessariamente privata della libertà di azione per la sola ragione che le decisioni che la riguardano sono prese dall’ente pubblico che la detiene, se essa può esercitare ancora una parte importante della sua attività economica presso altri operatori.
62 È inoltre necessario che le prestazioni di detta impresa siano sostanzialmente destinate in via esclusiva all’ente locale in questione. Entro tali limiti, risulta giustificato che l’impresa di cui trattasi sia sottratta agli obblighi della direttiva 93/36, in quanto questi ultimi sono dettati dall’intento di tutelare una concorrenza che, in tal caso, non ha più ragion d’essere.
63 In applicazione di detti principi, si può ritenere che l’impresa in questione svolga la parte più importante della sua attività con l’ente locale che la detiene, ai sensi della menzionata sentenza Teckal, solo se l’attività di detta impresa è principalmente destinata all’ente in questione e ogni altra attività risulta avere solo un carattere marginale.
64 Per verificare se la situazione sia in questi termini il giudice competente deve prendere in considerazione tutte le circostanze del caso di specie, sia qualitative sia quantitative.
65 Quanto all’accertare se occorra tener conto in tale contesto solo del fatturato realizzato con l’ente locale controllante o di quello realizzato nel territorio di detto ente, occorre considerare che il fatturato determinante è rappresentato da quello che l’impresa in questione realizza in virtù delle decisioni di affidamento adottate dall’ente locale controllante, compreso quello ottenuto con gli utenti in attuazione di tali decisioni.
66 Infatti, le attività di un’impresa aggiudicataria da prendere in considerazione sono tutte quelle che quest’ultima realizza nell’ambito di un affidamento effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia la stessa amministrazione aggiudicatrice o l’utente delle prestazioni.
67 Non è rilevante sapere chi remunera le prestazioni dell’impresa in questione, potendo trattarsi sia dell’ente controllante sia di terzi utenti di prestazioni fornite in forza di concessioni o di altri rapporti giuridici instaurati dal suddetto ente. Risulta parimenti ininfluente sapere su quale territorio siano erogate tali prestazioni.
68 Dal momento che, nella causa principale, il capitale dell’impresa aggiudicataria appartiene indirettamente a vari enti locali, può essere rilevante esaminare se l’attività da prendere in considerazione sia quella che l’impresa aggiudicataria realizza con tutti gli enti che la detengono o soltanto quella realizzata con l’ente che, nel caso specifico, agisce in qualità di amministrazione aggiudicatrice.
69 A tale proposito si deve rammentare che, secondo quanto precisato dalla Corte, la persona giuridicamente distinta di cui trattasi deve realizzare la parte più importante della propria attività “con l’ente o con gli enti locali che la controllano” (sentenza Teckal, cit., punto 50). La Corte ha quindi contemplato la possibilità che l’eccezione prevista si applichi non solo all’ipotesi in cui un solo ente pubblico detenga una siffatta persona giuridica, ma anche a quella in cui la detengano più enti.
70 Nel caso in cui diversi enti locali detengano un’impresa, la condizione relativa alla parte più importante della propria attività può ricorrere qualora l’impresa in questione svolga la parte più importante della propria attività non necessariamente con questo o quell’ente locale ma con tali enti complessivamente considerati.
71 Di conseguenza, l’attività da prendere in considerazione nel caso di un’impresa detenuta da vari enti locali è quella realizzata da detta impresa con tutti questi enti.
72 Dalle considerazioni che precedono deriva che si deve risolvere la seconda parte della seconda questione nel senso che, nel valutare se un’impresa svolga la parte più importante della sua attività con l’ente pubblico che la detiene, al fine di decidere in merito all’applicabilità della direttiva 93/36, si deve tener conto di tutte le attività realizzate da tale impresa sulla base di un affidamento effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente da chi remunera tale attività, potendo trattarsi della stessa amministrazione aggiudicatrice o dell’utente delle prestazioni erogate, mentre non rileva il territorio in cui è svolta l’attività. (Omissis)
(1-2) Diritto societario e in house providing
Articoli Correlati: diritto societario - In house providing - 11 maggio 2006
1. Il caso - 2. La giurisprudenza della Corte di Giustizia - 3. La giurisprudenza nazionale - 4. Il quadro normativo di riferimento - 5. Il commento - NOTE
Con la sentenza del 11 maggio 2006, che qui si pubblica, la Corte di Giustizia, mantenendosi nel solco tracciato dalla propria giurisprudenza a partire dalla seconda metà degli anni ’90, torna sul controverso tema degli affidamenti in house, aggiungendo un ulteriore tassello all’opera di definizione dell’ambito di operatività della eccezione (c.d. “eccezione Teckal” [1]) alle procedure di affidamento previste dal sistema delle direttive comunitarie in materia di pubblici appalti. La vicenda trova il proprio teatro nel territorio italiano e ha nel nostro giudice amministrativo uno dei suoi protagonisti. Il 18 dicembre 2003, il Comune di Busto Arsizio procedeva alla sospensione, prima, ed alla revoca, poi, di una gara di appalto, già bandita, per la fornitura di combustibili, la manutenzione, l’adeguamento normativo e la riqualificazione tecnologica degli impianti termici degli edifici comunali [2]. Successivamente lo stesso Comune procedeva all’affidamento in via diretta alla AGESP s.p.a., società controllata al 100% dalla società AGESP Holding s.p.a., il cui capitale apparteneva per il 99,98% al Comune di Busto Arsizio e per la parte restante ad alcuni comuni limitrofi. La Carbotermo s.p.a. ed il Consorzio Alisei, due partecipanti alla gara di appalto originariamente bandita dal Comune di Busto Arsizio, impugnavano le deliberazioni con le quali il Comune, da una parte, aveva prima sospeso e poi revocato la gara, e, dall’altra, aveva assegnato l’appalto che ne costituiva l’oggetto senza previo esperimento di una delle procedure ad evidenza pubblica previste dal sistema delle direttive appalti. Il TAR, dopo aver riunito i ricorsi, si rivolgeva alla Corte di Giustizia per la risoluzione di due questioni pregiudiziali. In base alla prima, la Corte veniva interrogata in ordine alla compatibilità con il diritto comunitario (e segnatamente con la direttiva 93/36/CEE) dell’affidamento diretto di un appalto per la fornitura di beni e servizi (con prevalenza del valore della fornitura) ad una società per azioni (la AGESP s.p.a.), il cui capitale è interamente detenuto dal Comune di Busto Arsizio, seppure tramite altra s.p.a. partecipata per il 99,98% dalla stessa amministrazione aggiudicatrice e per il residuo 0,2% da altre amministrazioni locali. Con la seconda questione si chiedeva invece ai giudici comunitari [continua ..]
Benché l’espressione “in house contract” sia stata utilizzata in ambito comunitario per la prima volta nella Comunicazione della Commissione (98) 143 [4], quella dell’in house providing è una figura di creazione eminentemente giurisprudenziale elaborata nelle decisioni della Corte di Giustizia. Alla luce di tali decisioni gli affidamenti in house si configurano come una eccezione alle regole di fonte comunitaria in tema di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. Prima ancora che ve ne fosse traccia nelle sentenze dei giudici del Lussemburgo, però, significativi passi verso la delimitazione dei confini dell’in house providing erano stati compiuti da parte degli Avvocati generali presso la Corte di Giustizia. Nelle conclusioni rassegnate dall’Avvocato generale nella causa BFI Holding BV [5], ad esempio, sembra già potersi riconoscere l’idea, alla base della successiva giurisprudenza in tema di in house providing, secondo la quale le amministrazioni pubbliche che necessitano di beni o servizi sono libere di esternalizzare senza necessità di rispettare le norme in tema di procedure ad evidenza pubblica, sempre che si rivolgano a soggetti che, pur non potendosi dire interni all’amministrazione aggiudicatrice, siano legati a quest’ultima da un rapporto parificabile alla delegazione interorganica [6]. Nelle conclusioni presentate dall’Avvocato generale nella causa RI.SAN. S.r.l. [7] viene poi chiarito che l’eventuale qualificazione della società affidataria quale ente in house all’ente pubblico deve essere operata avendo riguardo al dato funzionale, e cioè accertando “in che misura la pubblica amministrazione controlla la società di cui si tratta”. Proprio tali affermazioni, sebbene ignorate dalla Corte di Giustizia in sede di decisione, costituiscono l’antecedente sul quale si basa il legal reasoning della successiva sentenza Teckal, alla quale unanimemente si suole ricondurre la prima teorizzazione del fenomeno dell’in house providing [8]. Con questa sentenza la Corte di Giustizia ha riconosciuto il tratto qualificante di questa figura nel fatto che in essa l’ente conferente esercita sull’affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e l’affidatario realizza la parte più importante della [continua ..]
La più recente giurisprudenza nazionale si è in generale uniformata agli esiti della elaborazione dell’in house providing operata dalla Corte di Giustizia. Dall’analisi delle sentenze dei giudici amministrativi italiani emergono, infatti, concetti e soluzioni che replicano, e talvolta anticipano, a livello interno, l’evoluzione che la fattispecie dell’in house providing ha conosciuto nella giurisprudenza comunitaria. Anche con riferimento alle pronunce nazionali si possono, dunque, isolare tre fasi, che, in parallelo alla graduale chiarificazione del rapporto che deve sussistere tra pubblica amministrazione ed ente in house ai fini della legittimità di un affidamento diretto, scandiscono il progressivo restringimento dell’ambito di applicabilità di questa figura. Nella prima fase, i giudici italiani, condizionati, per un verso, dalla ermetica formulazione delle condizioni di legittimità dell’in house providing contenuta nella sentenza Teckal [22], e, per altro verso, dalle indicazioni provenienti dalla legislazione interna sugli enti locali [23], hanno fornito una interpretazione particolarmente ampia della c.d. “eccezione Teckal”, ritenendo quest’ultima applicabile anche ai casi in cui alla società affidataria partecipino, con una quota minoritaria, soggetti privati [24]. Nella seconda fase, che ha preso avvio già nel 2004, mentre si registra una certa univocità di opinioni in ordine alla necessità della titolarità dell’intero capitale della società affidataria in capo a soggetti pubblici [25], il principale nodo problematico che i giudici amministrativi italiani si sono trovati a dover sciogliere è stato quello della sufficienza o meno di tale partecipazione pubblica totalitaria ai fini della integrazione del requisito del “controllo analogo”. Accanto a pronunce nelle quali si è messa in dubbio la sufficienza di una partecipazione pubblica totalitaria nella società affidataria [26], anche dopo la sentenza “Stadt Halle” [27], si rinvengono in Italia pronunce nelle quali si è escluso che il diritto comunitario possa esigere che i rapporti tra amministrazione aggiudicatrice e società affidataria vengano organizzati secondo un modulo identico a quello proprio dei rapporti tra la P.A. e le sue articolazioni interne. E [continua ..]
Si è visto come l’in house providing si configuri quale eccezione alle regole in tema di procedure di aggiudicazione previste dalle direttive comunitarie sugli appalti pubblici. Una eccezione il cui ambito di applicazione è stato progressivamente definito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, avendo riguardo, da un lato, alla libertà della pubblica amministrazione di auto-organizzarsi, e, dall’altro, ai principi in tema di libertà di concorrenza e di parità di trattamento. Conseguentemente, il quadro normativo di riferimento dell’in house providing a livello comunitario è formato, per un verso, dalle norme rispetto alle quali esso costituisce eccezione, ossia dalle citate direttive appalti [39], e, per altro verso, dalle norme di vertice che ne delimitano il perimetro applicativo, ossia dagli articoli del Trattato CE che contemplano i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento. Diversamente da quanto è accaduto a livello comunitario, ove l’in house providing non trova riferimenti normativi espliciti, a livello nazionale la figura ha trovato specifici spazi nell’ordinamento positivo, che oggi la contempla in più di una norma in maniera espressa. Il fenomeno ha avuto un formale riconoscimento normativo nel settore dei servizi pubblici locali, ove si possono rintracciare diverse previsioni, sia di rango primario sia di rango secondario, che operano un sostanziale recepimento dei criteri precisati a livello comunitario dai Giudici del Lussemburgo. Nell’ordinamento giuridico interno, la storia degli affidamenti diretti si lega, in particolare, per un verso, all’emanazione del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), e, per altro verso, alle procedure comunitarie di infrazione promosse contro l’Italia dalla Commissione europea in relazione proprio alla formulazione delle norme del T.U.E.L. in materia di affidamenti diretti di servizi pubblici locali. Il T.U.E.L., nella sua versione originaria, contemplava, all’art. 113, l’affidamento diretto di servizi pubblici, da parte di Comuni e Province, a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora, in relazione alla natura del servizio da erogare, si fosse resa opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati [40]. Successivamente, a seguito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, il legislatore nazionale [continua ..]
5.1. I presupposti dell’ in house providing nella prospettiva del diritto societario La sentenza in commento si colloca a pieno titolo in quel filone giurisprudenziale – come si è visto, consolidatosi tanto a livello comunitario quanto a livello nazionale –, ai sensi del quale la valutazione della legittimità di un affidamento diretto da parte di una pubblica amministrazione passa per la verifica del concreto assetto strutturale ed organizzativo della società affidataria, dimostrando la necessità di guardare all’in house providing attraverso la lente del diritto societario [50]. Riguardati da questa prospettiva, infatti, i concetti di “controllo analogo” e di “controllo operativo economico” permettono di individuare i tratti tipologici della società in house e, conseguentemente, di delineare di quest’ultima un profilo statutario idoneo a resistere alla prova dei principi comunitari. È questa tuttavia una operazione ermeneutica che presuppone la soluzione del preliminare problema relativo alla qualificazione del rapporto della società in house tanto con la fattispecie “società” contemplata dall’art. 2247 c.c. quanto con la fattispecie “impresa” di cui all’art. 2082 c.c. Il che, evidentemente, solleva questioni di particolare respiro sistematico, le quali possono essere affrontate avendo presenti alcuni principi desumibili dalla giurisprudenza comunitaria. Il primo principio discende dalla elaborazione giurisprudenziale del concetto di “controllo analogo” e può essere definito “principio della partecipazione pubblica totalitaria”. Alla stregua di questo principio il “controllo analogo” su una “società in house” si può configurare solo in presenza di una partecipazione totalitaria da parte di uno o più soggetti pubblici [51]. Il secondo principio, anch’esso desumibile dall’elaborazione giurisprudenziale del concetto di “controllo analogo”, può essere definito “principio dell’insufficienza della partecipazione pubblica totalitaria” e postula l’inesistenza di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la partecipazione totalitaria dell’amministrazione nella società affidataria, cui si è appena fatto cenno, e la [continua ..]