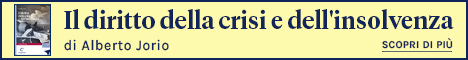
Non è mia consuetudine quale membro di collegi arbitrali formulare opinioni dissenzienti o concorrenti, e tanto meno farlo redigendo opinioni articolate ed argomentate come la presente. Tuttavia, la controversia che questo Tribunale Arbitrale è stato chiamato a decidere solleva delicate questioni sul rapporto tra autonomia negoziale e regolamento di mercato in relazione ad uno strumento, le opzioni “put” su partecipazioni azionarie di riferimento, frequentemente utilizzato nell’ambito delle operazioni di investimento. Anche in considerazione di recenti sviluppi giurisprudenziali che, lungi dal fare chiarezza, hanno complicato il quadro, e della necessità di assicurare agli operatori certezza e prevedibilità, tali questioni vanno risolte individuando con esattezza i limiti che nell’ordinamento italiano l’iniziativa economica privata incontra al suo, altrimenti libero e incondizionato, esplicarsi. Tra tali limiti rientra il divieto di patto leonino del quale l’arbitro, come il giudice, deve fare applicazione trovando il giusto equilibrio tra il diritto degli imprenditori di auto-regolare i propri interessi ed il diritto dello Stato di rendere tale auto-regolamento compatibile con l’interesse generale, anche in una prospettiva di interpretazione orientata dall’art. 41 Cost. Il Lodo, sulla base di una lettura dell’art. 2265 c.c. e degli accordi tra le Parti, certo possibile, ma a mio avviso non corretta, non realizza tale equilibrio nella parte in cui, da un lato, legittima una pattuizione idonea a produrre proprio gli effetti che il divieto di patto leonino mira a scongiurare, dall’altro ricostruisce la volontà delle Parti nello stipulare gli accordi per cui è lite non dando rilievo a vari atti delle Parti stesse ed agli usi prevalenti sul mercato in cui le Parti operano.
Milano, 30 maggio 2019.
Articoli Correlati: patto leonino - opzione put
Premessa - A. L’invalidità dell’Opzione per contrarietà al divieto di patto leonino - I. L’applicabilità del divieto di patto leonino ad opzioni per la compravendita di partecipazioni azionarie - II. La valutazione dell’Opzione ai sensi dell’art. 2265 c.c. - B. Il rigetto delle domande convenzionali in ragione del contenuto del negozio che sarebbe venuto a esistenza tra le Parti per effetto dell’esercizio dell’Opzione - I. L’esercizio dell’Opzione come fonte di un contratto definitivo di compravendita ad efficacia differita - II. Il differimento degli effetti traslativi alla data del “Closing” - III. La conseguente infondatezza delle domande riconvenzionali svolte dalla Convenuta sul presupposto della validità dell’Opzione - NOTE
1. Dissento dal lodo deliberato a maggioranza dai miei illustri co-arbitri, pur apprezzandone le acute ed eleganti motivazioni e pur condividendo molte delle decisioni sulle questioni di fatto e di diritto controverse in esso contenute, in quanto è mio meditato convincimento che (1) la domanda di A. S.p.a. (l’“Attrice”) vada accolta, essendo l’opzione di cui al punto [*] del contratto in data [*] (rispettivamente, l’“Opzione” e il “Contratto”) nulla per contrasto con il divieto di patto leonino di cui all’art. 2265 c.c., e (2) le domande riconvenzionali di B S.p.a. (la “Convenuta”) vadano comunque rigettate in ragione del contenuto del negozio che sarebbe venuto a esistenza tra le Parti per effetto dell’esercizio dell’Opzione, ove questa avesse potuto essere validamente esercitata. 2. Ritengo infatti, per le ragioni qui di seguito esposte, che effetto dell’Opzione sia quello di attribuire alla Convenuta la facoltà di sciogliersi dal contratto sociale, senza correre in alcun modo il rischio dell’impresa comune, qualora, nella sua più assoluta ed insindacabile discrezione, essa ritenga di non essere più interessata al progetto di [*] (l’“Operazione”) di cui all’Accordo di Investimento in data [*] (l’“Accordo di Investimento”) ed in vista della cui realizzazione X S.p.a. (la “Società”) è stata costituita. Ciò lede l’interesse alla cui tutela mira il divieto di patto leonino, giacché disincentiva l’esercizio avveduto e corretto da parte della Convenuta dei diritti amministrativi di cui essa gode sia quale socio detentore di azioni rappresentative del [*]% del capitale sociale della Società (la “Partecipazione”), sia quale parte dell’Accordo di Investimento. 3. Ritengo, inoltre, che nella propria autonomia negoziale le Parti hanno concordato che l’esercizio dell’Opzione perfezionerebbe un contratto definitivo di compravendita con efficacia differita alla data in cui, in un unico contesto e con l’esecuzione di adempimenti reciprocamente condizionati, avrebbero luogo il trasferimento della proprietà della Partecipazione dalla Convenuta all’Attrice, il pagamento del corrispettivo dall’Attrice alla Convenuta, e le operazioni di transfert necessarie per rendere opponibile alla [continua ..]
4. L’art. 2265 c.c., rubricato “patto leonino”, dispone che «è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite». 5. Come noto, l’applicabilità della norma ad opzioni di acquisto o di vendita di partecipazioni azionarie a prezzo predeterminato è da tempo dibattuta.[1] Contrariamente a quanto ritenuto dai primi commentatori, non credo che la questione possa considerarsi definitivamente risolta da due recenti pronunzie della Corte di Cassazione[2]. Queste pronunzie, coeve e redatte da uno stesso relatore, non convincono né quando dichiarano che l’art. 2265 c.c. può trovare applicazione solo quando il patto leonino sia contenuto nello statuto della società, né quando, con tortuose motivazioni e nell’ambito di un obiter dictum, trattano della liceità di accordi extra-statutari in cui l’esclusione dagli utili o dalle perdite sia giustificata da una causa (concreta) meritevole di tutela [3]. Anche in considerazione del fatto che entrambe le Parti hanno fatto ampio riferimento a tali pronunzie, e che l’interpretazione data all’art. 2265 c.c. dai miei illustri co-arbitri mi trova concorde solo in parte, devo preliminarmente, e brevemente, chiarire se e in che misura sia a mio avviso corretto applicare il divieto di patto leonino ad opzioni per la compravendita di partecipazioni azionarie (I). Tale premessa definisce l’indagine che a mio avviso va poi condotta per valutare se l’Opzione sia o meno in contrasto con l’art. 2265 c.c. (II).
6. Come noto, la norma di cui all’art. 2265 c.c. è dettata nell’ambito della disciplina della società semplice e trova applicazione alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice per effetto del rinvio disposto rispettivamente dagli artt. 2293 c.c. e 2315 c.c. Sulla sua applicabilità alle società di capitali in difetto di una espressa previsione del legislatore, peraltro assunta da entrambe le Parti nei rispettivi scritti difensivi, concordano dottrina[4] e giurisprudenza[5] ritenendo che l’art. 2265 c.c. esprima un principio generale del diritto societario. Credo si debba tuttavia convenire con chi ha sostenuto [6] che l’estensione del divieto di patto leonino alle società di capitali consegua da una applicazione analogica della disposizione, e sia da ritenere quindi possibile solo quando gli interessi tutelati dall’art. 2265 c.c. risultino parimenti compromessi in considerazione delle regole di organizzazione della società di capitali in rilievo, quali risultanti dal modello legislativo e delle deroghe ad esso eventualmente apportate dalle parti nell’esercizio della propria autonomia. 7. Ciò impone di chiarire preliminarmente quale sia la ratio del divieto di patto leonino. 8. Come noto, nella disciplina codicistica della società di persone i due corni del divieto – affermatisi storicamente con funzioni diverse (tutelare la causa del negozio societario per quanto riguarda l’esclusione del socio dagli utili, contrastare l’usura per quanto riguarda l’esclusione del socio dalle perdite)[7] – hanno un fondamento unitario[8]. Secondo la Corte di Cassazione in quello che resta il leading case in materia, la disposizione dell’art. 2265 c.c. persegue infatti l’“obbiettivo di politica economica” di “rendere tutti i membri del gruppo” sociale “partecipi del rischio d’impresa conseguente alla attività svolta, al fine di garantire, nell’interesse generale, un esercizio avveduto e corretto dei relativi poteri”, e ciò sul duplice presupposto che l’immunità dagli utili crea il rischio di comportamenti orientati da un eccesso di cautela, mentre l’immunità dalle perdite compromette quello che di regola è “un sufficiente stimolo a spingere il socio ad astenersi da operazioni [continua ..]
16. La prima questione da risolvere è se l’art. 2265 c.c. trovi tout court applicazione nel caso di specie, considerato che la Società è una società di capitali e che la Convenuta è un socio di minoranza, detentore di una partecipazione pari all’[*]% del capitale sociale. 17. La questione deve avere risposta positiva. La dottrina ha individuato come ipotesi in cui l’applicazione analogica dell’art. 2265 c.c. a società di capitali è giustificata quella in cui un socio di una s.a.p.a. o di una s.r.l., “entusiasta di un suo progetto, pur di realizzarlo attribuisca ai potenziali finanziatori non solo tutti i diritti tipici dei soci, ma anche tutti i diritti tipici di chi presta denaro a interesse”[26]. Questa stessa dottrina ammette che si possano dare anche altre ipotesi di applicazione analogica. Una di tali altre ipotesi è, a mio avviso, quella delle società-progetto, o joint ventures in forma societaria, e cioè, per dirla con l’art. 2341-bis, comma 3, c.c., società interamente possedute dalle parti di un accordo di collaborazione per la produzione o lo scambio di beni o servizi che siano strumentali alla realizzazione di tale collaborazione. Anche nelle società-progetto, infatti, c’è di solito un socio promotore che cerca di aggregare intorno alla propria iniziativa altri partners. Inoltre, le società-progetto hanno di solito una base sociale ristretta e vedono attribuiti ai soci, nell’accordo di collaborazione o in patti parasociali ad esso accessori, poteri amministrativi/gestori ulteriori e diversi rispetto a quelli che ad essi spetterebbero per legge in virtù delle quote di partecipazione al capitale sociale detenute. Il rischio che in presenza di un patto leonino tali poteri possano essere esercitati in modo non avveduto e corretto, così pregiudicando l’interesse generale a che sul mercato non si tengano comportamenti ispirati da moral hazard, sussiste in questa fattispecie come sussisterebbe qualora le parti della joint venture avessero deciso di attuarla per il tramite di una società di persone (o di una s.a.p.a.). 18. È pacifico tra le Parti[27], e provato dai documenti agli atti[28], che la Società è una società-progetto costituita da un numero limitato di soci (cinque) [29] al fine esclusivo di realizzare l’Operazione, e [continua ..]
34. Per effetto dell’esercizio dell’Opzione, ove questa fosse validamente stipulata, non si perfezionerebbe un contratto preliminare di compravendita, bensì un contratto definitivo di compravendita con efficacia differita (I). In particolare, il contratto troverebbe esecuzione ad una data (di “Esecuzione” o di “Closing”, secondo le definizioni contrattuali) in cui, contestualmente e come “atto unico ed inscindibile”, (i) la Convenuta trasferirebbe la proprietà della Partecipazione all’Attrice, (ii) le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza e con la cooperazione degli amministratori della Società, darebbero corso alle operazioni di transfert, e (iii) l’Attrice pagherebbe alla Convenuta il corrispettivo (II). In ragione del contenuto del negozio opzionario così pattuito tra le Parti, nessuna delle domande svolte in via riconvenzionale dalla Convenuta sul presupposto della accertata validità dell’Opzione può essere accolta (III).
35. Il Contratto prevede che nel caso in cui si sia verificata per qualsivoglia motivo la condizione del mancato affidamento dalla Società alla Società C, o a una sua consorziata, degli appalti la Convenuta “avrà il diritto potestativo di vendere” all’Attrice, e l’Attrice in tal caso “si obbliga ad acquistare” tutto o quota parte della Partecipazione, “per un corrispettivo pari [a quanto][49] versato dalla Società C o dalla Convenuta in relazione alla Partecipazione della Convenuta, anche a titolo di finanziamento soci, al netto di quanto ricevuto per distribuzione di utili o riserve o rimborsi. Il saldo così ottenuto sarà maggiorato degli interessi di mercato. La Convenuta potrà esercitare il suddetto diritto di vendita a mezzo lettera raccomandata a.r. nella quale dovrà indicare la quota di partecipazione che intende vendere, nonché specificare il corrispettivo e gli interessi. L’acquisto dovrà avvenire entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della lettera raccomandata, indipendentemente dalla pendenza di eventuali contestazioni sulle cause del mancato perfezionamento dei punti di cui alla citata lettera B) che precede”[50]. 36. È innanzitutto il dato letterale ad indicare che l’Opzione ha per oggetto un contratto definitivo anziché un contratto preliminare di compravendita. Infatti: (i) in nessun luogo il Contratto fa menzione della necessità che una volta esercitata l’Opzione le Parti siano obbligate a stipulare un contratto definitivo, né dichiara che per effetto della comunicazione di esercizio verrà ad esistenza un contratto preliminare, pattuizioni queste ultime che la prassi indica usuali quando la volontà dei paciscenti sia appunto nel senso di ricorrere a quel particolare strumento che è l’opzione di preliminare; (ii) l’uso del tempo futuro con riguardo al diritto di vendere della Convenuta, ma del tempo presente con riguardo all’obbligo di acquistare di Attrice, indica che con la stipulazione dell’Opzione l’Attrice proponeva irrevocabilmente ex art. 1331 c.c. che a fronte della manifestazione futura (ed eventuale) della volontà della Convenuta di accettare la proposta stessa l’Attrice avrebbe dato esecuzione ad una compravendita, e non alla stipulazione di un nuovo negozio, giacché in questa diversa [continua ..]
50. Per gli stessi motivi mi sembra indubitabile che la volontà delle parti si sia espressa: da un lato, nel senso di derogare al principio consensualistico prevedendo che il trasferimento della proprietà delle azioni opzionate avvenga non contestualmente all’esercizio della Opzione ed al conseguente perfezionarsi del negozio di compravendita, bensì alla data (successiva) della “Esecuzione” (per riprendere la terminologia utilizzata nel Contratto di Esercizio dell’Opzione) ovvero del “Closing” (per riprendere la terminologia utilizzata nella Comunicazione di Esercizio della Prelazione); dall’altro, nel senso di disporre che tale trasferimento sia condizionato al contestuale perfezionamento di vari atti, e in particolare del pagamento del corrispettivo e del compimento delle operazioni di transfert. Questo schema è stato seguito, in linea di principio,[62] in sede di esecuzione della compravendita conseguente al primo atto di esercizio della Opzione, ed è comunque anch’esso conforme alle prassi di mercato. 51. L’interpretazione dell’Opzione per cui il trasferimento della proprietà debba ritenersi perfezionato solo se è intervenuto il pagamento del corrispettivo e siano state compiute, con la cooperazione degli amministratori, le operazioni di transfert necessarie per rendere opponibile la cessione alla Società risponde, peraltro, ad un criterio di ragionevolezza e buona fede, giacché solo in tal modo si tutelano pienamente gli opposti interessi della parte venditrice a ricevere il prezzo e della parte acquirente a poter esercitare i propri diritti patrimoniali e amministrativi nei confronti della Società, garantendo ad entrambe le parti la simultanea realizzazione del sinallagma contrattuale.
52. L’interpretazione dell’Opzione più su proposta si impone in quanto conforme al dato letterale e a quella che appare la comune intenzione dei contraenti in considerazione del loro comportamento complessivo, anche dopo la stipulazione del contratto (art. 1362 c.c.), nonché degli usi di mercato rilevanti quale fonte integrativa (art. 1340 c.c.) o pratica interpretativa (art. 1368 c.c.) dei quali, come si diceva, questo Tribunale Arbitrale deve comunque tener conto. Da questa interpretazione discende anche l’infondatezza delle domande riconvenzionali proposte dalla Convenuta sul presupposto della validità dell’Opzione. 53. La Convenuta, infatti, svolge una serie articolata di domande chiedendo che il Tribunale Arbitrale, una volta accertata “la legittimità dell’esercizio” (ergo, considerata la domanda dell’Attrice, la validità) dell’Opzione, pronunzi (i) in via principale un lodo dichiarativo della “già intervenuta cessione in data [*]”[63] della Partecipazione, (ii) in via subordinata un “(l)odo traslativo ai sensi dell’art. 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto di vendita non concluso” ovvero (iii) sempre in via subordinata, un lodo “(c)he disponga comunque il trasferimento” della Partecipazione, e “in ogni caso”, in via principale, (iv) un lodo contenente “ogni conseguente pronunzia relativa alle formalità prescritte dalla legge per l’opponibilità del trasferimento” delle azioni compravendute alla Società, nonché (v) un lodo di condanna dell’Attrice a pagare alla Convenuta “il corrispettivo della vendita, pari a EUR [*] milioni, oltre agli interessi calcolati nella misura di mercato ([*]% in ragione d’anno), pari ad EUR [*] milioni alla data del [*], per un corrispettivo complessivo pari ad EUR [*] milioni, oltre interessi successivi fino alla data del pagamento”. 54. Nessuna di queste domande può a mio avviso essere accolta. 55. Quanto alla domanda sub (i), è palese che nessuna cessione sia intervenuta alla data del [*], vale a dire contestualmente alla Comunicazione di Esercizio dell’Opzione. L’Opzione prevede espressamente, come si è visto, che il trasferimento avvenga entro i 30 giorni successivi all’esercizio dell’Opzione, e la Comunicazione di Esercizio della Prelazione [continua ..]