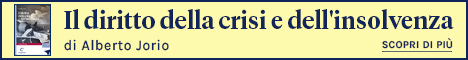
Articoli Correlati: stato arte - ipotesi - ricognizione - processo commerciale - fattispecie estintive
1. Premessa - 2. La cancellazione della causa dal ruolo nel passaggio dal rito ordinario al rito commerciale - 3. La notificazione tardiva dell'istanza di fissazione d'udienza: gli eventi estintivi individuati dal legislatore - 4. (Segue). La mancata notificazione dell'istanza di fissazione d’udienza - 5. (Segue). La mancata o tardiva notificazione dell'istanza di fissazione d'udienza: il dies a quo ai fini del computo del termine prescritto a pena di estinzione - 6. (Segue). La mancata o tardiva notificazione dell'istanza di fissazione d'udienza: il dies a quo ai fini del computo del termine prescritto a pena di estinzione nei processi con pluralità delle parti - 7. (Segue). La questione al vaglio della Corte costituzionale - 8. (Segue). La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza al convenuto contumace: le prassi applicative - 9. (Segue). Il mancato tempestivo deposito dell’istanza di fissazione d’udienza - 10. (Segue). L'istanza di fissazione d’udienza quale mezzo di eccezione di estinzione - 11. La mancata tempestiva costituzione dell'attore - 12. La mancata tempestiva costituzione di tutte le parti - 13. La mancata comparizione di tutte le parti costituite all'udienza - 14. La mancata comparizione di tutte le parti nel procedimento in grado di appello - 15. Le ipotesi di inattività delle parti rivenienti dal codice di rito - 16. La rinuncia agli atti - NOTE
La questione relativa alla ricognizione delle fattispecie estintive del processo commerciale e l’analisi della disciplina prevista dal d.leg. 17 gennaio 2003, n. 5, hanno più volte sollecitato l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza di merito. Quattro anni dopo l’entrata in vigore, prima di una pronuncia chiarificatrice dell’organo nomofilattico, appare opportuno tentare di fare il punto della situazione. Nella verifica delle diverse prassi applicative del processo ordinario a cognizione piena è emerso che, sovente, quest’ultimo si conclude prima ancora che il giudice provveda sulla domanda, perché le parti non hanno più interesse alla decisione ovvero rimangono inerti per un determinato lasso di tempo. In queste ipotesi, il processo si chiude secondo forme diverse dalle regole comuni dettate in tema di decisione della causa: differente è, infatti, non solo il contenuto del provvedimento finale, ma anche il procedimento e i termini processuali per mezzo dei quali si perviene alla definizione del giudizio. Tali forme sono espressamente previste dagli artt. 306 ss. del codice di rito. Nonostante il diverso sistema processuale, il legislatore delegato alla disciplina del nuovo rito commerciale si avvale di uno schema normativo analogo, pur con alcune novità non del tutto secondarie. In particolare, mentre alcune disposizioni ricalcano la disciplina comune, sicché i dubbi interpretativi sorti in applicazione della medesima si ripropongono nel processo commerciale, trovando alcuni di questi una soluzione adeguata, altre disposizioni introducono nuove fattispecie con nuove forme e con termini predeterminati in parte diversi, per mezzo dei quali il giudice è chiamato a provvedere. La ricognizione e l’analisi degli eventi estintivi indicati dal legislatore, da un lato, e l’esame di quegli eventi che, pur non espressamente previsti, possono verificarsi nel processo commerciale, dall’altro, forniscono i dati indispensabili per individuare le linea guida dell’indagine. Lo studio di ogni singola fattispecie estintiva, infatti, consente di verificare se il meccanismo processuale, previsto per la dichiarazione di estinzione all’art. 12, 5° comma, dello stesso decreto, possa funzionare per ognuna di queste, se possa essere avviato in ogni momento del processo instaurato ovvero se debba operare soltanto nel corso della fase che si svolge [continua ..]
Per una puntuale ricognizione delle fattispecie estintive che si configurano nel processo commerciale, è opportuno iniziare l’analisi dagli eventi espressamente individuati dal legislatore delegato. Punto di partenza è l’art. 1, 5° comma, per effetto del quale, nelle ipotesi in cui una causa relativa ad uno dei rapporti di cui al 1° comma è stata proposta in forme diverse da quelle previste dallo stesso decreto, il giudice istruttore deve, all’udienza di comparizione, ovvero successivamente [2], disporre con ordinanza il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo. Dalla comunicazione della ordinanza decorrono, se emessa a seguito dell’udienza di comparizione, i termini di cui all’art. 6, fissati all’attore per notificare al convenuto (e depositare in cancelleria) la memoria di replica [3] ovvero, in ogni altro caso, i termini di cui all’art. 7, indicati per le repliche ulteriori. A ben vedere tale disciplina si differenzia da quella dettata per le altre ipotesi di mutamento di rito. Infatti, negli artt. 426 e 427 c.p.c., l’errore sul rito, rilevabile d’ufficio, comporta che il giudice debba provvedere disponendo le forme e i termini per l’eventuale integrazione degli atti introduttivi, senza però disporre la cancellazione della causa dal ruolo. La norma speciale, invece, prevede che il giudice, con la stessa ordinanza con la quale dispone il mutamento del rito, provveda contestualmente alla cancellazione della causa dal ruolo. Dell’esatta portata di tale istituto nell’ambito del processo commerciale si è ampiamente discusso in giurisprudenza e in dottrina. Secondo una prima lettura, l’oggetto della cancellazione va individuato nel ruolo generale del tribunale. Tale lettura non è però condivisibile, dal momento che l’attore, dopo la notifica dell’atto di citazione (o il convenuto, nel caso di inerzia dell’attore), si costituisce in giudizio ed iscrive pertanto la causa al ruolo generale [4], e che tale iscrizione permane anche dopo l’ordinanza di cancellazione della causa da ruolo in quanto: a) il giudice competente è sempre quello originariamente adito e il solo errore sul rito non comporta uno spostamento della causa innanzi ad un giudice diverso; b) l’art. 1, 5° comma, contempla lo scambio degli atti successivi a quelli introduttivi (citazione e [continua ..]
L’originaria formulazione dell’art. 8, 4° comma, del decreto delegato limitava l’estinzione soltanto ai casi in cui le parti non avevano provveduto alla notificazione dell’istanza di fissazione d’udienza nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all’art. 7, 2° comma [12], ovvero alla scadenza del termine massimo di cui all’art. 7, 3° comma. L’art. 4 del decreto delegato correttivo 6 febbraio 2004, n. 37 ha modificato tale norma e ha aggiunto che l’estinzione del processo è determinata anche dalla mancata notificazione dell’istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 [13]. Il testo vigente pone alcune riflessioni. La prima riguarda la parte del 4° comma introdotta dal decreto correttivo, per la quale anche «la mancata notifica dell’istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti» determina l’estinzione del processo. Tale disposizione avrebbe dovuto comportare quantomeno l’eliminazione di quella concernente la memoria di controreplica: a ben vedere, infatti, la previsione dell’estinzione allorché alla notifica dell’istanza di fissazione di udienza non si provveda nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai primi tre commi dell’art. 8, tende ad assorbire l’ipotesi della mancata notifica dell’istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all’art. 7, 2° comma. La seconda notazione concerne l’altra fattispecie estintiva prevista dall’art. 8, 4° comma, ossia quella per la quale il processo si estingue se le parti abbiano omesso di provvedere alla notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza nei venti giorni successivi dalla [14] scadenza del termine massimo di cui all’art. 7, 3° comma, e cioè del termine di ottanta giorni dalla notifica della memoria di controreplica di cui al 2° comma dello stesso articolo [15]. In particolare, l’evento estintivo indicato presuppone lo svolgimento di una complessa attività difensiva: invero, l’attore ha notificato al convenuto [continua ..]
L’art. 8, 4° comma, pone all’interprete un’ulteriore notazione: la norma si riferisce alle ipotesi in cui l’istanza di fissazione dell’udienza sia stata notificata fuori termine; nulla dispone per il caso in cui le parti non provvedano a notificare la predetta istanza neppure tardivamente. Come è noto, l’istanza è l’atto attraverso il quale si chiude la fase privata del processo e si avvia quella ex art. 12, nella quale il cancelliere presenta senza indugio al presidente il fascicolo d’ufficio contenente tutti gli atti e documenti depositati dalle parti, per la designazione del giudice relatore; entro cinquanta giorni da quest’ultima, il relatore sottoscrive e deposita il decreto di fissazione dell’udienza. Ora, se l’istanza non viene notificata, è evidente che non vi è un giudice designato che possa, su eccezione della parte interessata ovvero d’ufficio, se nessuna delle parti compare all’udienza, dichiarare l’estinzione, né un’udienza in cui potervi provvedere [17]. Così come è evidente che, se l’istanza viene depositata, il giudice, all’uopo designato, potrà dichiarare l’estinzione [18]. Peraltro, non si può escludere che le parti, pur avendo abbandonato il processo e non presentato in termini l’istanza di fissazione di udienza, decidano di proporre successivamente la questione sull’estinzione con la conseguenza che: a) l’estinzione sia oggetto di eccezione in una successiva memoria notificata dalla parte interessata al fine di innescare comunque lo speciale subprocedimento ex art. 12, 5° comma; b) l’estinzione costituisca l’oggetto di una cognizione incidenter tantum in un secondo e autonomo processo in cui, riproposta la stessa domanda, ed eccepita la litispendenza, il giudice dichiari estinto il primo processo al solo fine di rigettare l’eccezione proposta [19].
Il combinato disposto del 4° comma dell’art. 8 con i commi 1°, 2° e 3° della medesima norma costituisce un’ulteriore ragione di riflessione. Sin dalle prime applicazioni pratiche del nuovo rito commerciale, il tema relativo alla ritualità dell’istanza di fissazione dell’udienza è stato più volte affrontato dai giudici di merito; molteplici sono state le questioni trattate, ma alcune di queste rimangono ad oggi irrisolte. In particolare, si è discusso e si discute sul dies a quo ai fini del computo del termine previsto a pena di estinzione per la notificazione dell’istanza: l’art. 8, 4° comma, lascia spazio a diverse letture interpretative nella parte in cui prevede che «la mancata notifica dell’istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti […] determina l’estinzione del processo […]». Un primo dubbio riguarda la parola «successivi» (venti giorni) alla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi (1°, 2° e 3°). In particolare, ci si è chiesti se tale aggettivo debba intendersi oppure no nel senso di ulteriori rispetto a quei termini e se quei termini giungano a scadenza allorché siano decorsi inutilmente venti giorni dai diversi dies a quibus individuati dalle lett. a), b) e c) dei commi 1°, 2° e 3°; e se, pertanto, l’istanza di fissazione dell’udienza debba essere ritualmente notificata nel termine di giorni 20, di cui all’art. 8, 4° comma, più giorni 20, di cui all’art. 8, 1°, 2° o 3° comma (in totale 40 giorni) [20]. Un secondo dubbio concerne l’inciso «dei termini di cui ai commi precedenti» (1°, 2° e 3°), nel senso che non è chiaro di quali termini si tratti; se: quelli indicati nelle lett. a), b) e c) dei commi 1°, 2° e 3°, ovvero quegli stessi termini di cui alle lett. a), b) e c) aumentati dei venti giorni indicati nella prima parte dei rispettivi commi 1°, 2° e 3°. La soluzione prospettata dalle prime pronunce di merito [21] e, in un primo momento, condivisa da chi scrive in alcune osservazioni in nota ad un provvedimento del Tribunale di Milano [22], è nel senso che il termine di venti giorni, previsto a pena di estinzione, per la notificazione dell’istanza di [continua ..]
Per i processi con pluralità di parti, l’individuazione del dies a quo ai fini del calcolo del termine prescritto a pena di estinzione del processo per la notificazione dell’istanza di fissazione d’udienza, richiede un dato ulteriore. Il complesso di norme introdotto dal d.leg. 28 dicembre 2004 n. 310, correttivo del d.leg. n. 5/2003 [31], atte a funzionare nel processo con pluralità di parti, non disciplina in modo specifico il momento a partire dal quale debba decorrere il termine previsto per la notificazione dell’istanza di fissazione d’udienza, allorché lo scambio degli atti sia avvenuto tra più soggetti (pensiamo all’ipotesi – tutt’altro che infrequente – di un’azione di responsabilità promossa nei confronti degli amministratori e dei sindaci, i quali, a loro volta, abbiano chiamato in causa le rispettive compagnie di assicurazione). Con specifico riguardo alla legittimazione passiva dei litisconsorti, il dato normativo secondo il quale l’istanza di fissazione d’udienza deve essere notificata «alle altri parti» (art. 8) sta a significare che la predetta istanza debba essere notificata a tutte le altre parti, e non soltanto ad una o ad alcune di esse. Tale atto, infatti, costituisce l’anello di congiunzione della fase assertiva con quella apud iudicem per l’intero processo, sì da non poter riguardare una o alcune soltanto delle cause riunite; ogni litisconsorte è legittimato a notificare l’istanza di fissazione d’udienza e, allo stesso modo, ogni litisconsorte deve poter conoscere che altra parte ha già provveduto a sollecitare l’intervento del giudice. Ne consegue che la fase preparatoria non possa che cessare o proseguire in modo identico per tutte le parti e per tutte le controversie; si esclude, infatti, che «le cause riunite abbiano sviluppi diversi» nella consapevolezza che esse, «almeno durante tutta la fase preparatoria, non sono né scindibili, né separabili» [32]. Peraltro, se l’istanza non viene notificata a tutte le altre parti e le cause sono scindibili, la giurisprudenza di merito ha sostenuto l’estinzione parziale del processo [33]; con la conseguenza che, se le cause sono inscindibili, l’estinzione dovrà riguardare l’intero processo. Ora, però, perché l’istanza [continua ..]
Sulla problematica affrontata nei paragrafi che precedono, di recente è stato richiesto, in due distinte occasioni, l’intervento della Corte costituzionale dal Tribunale di Milano [37], che ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 8, 4° comma, d.leg. n. 5/2003 nella parte in cui stabilisce che «la mancata notifica dell’istanza di fissazione d’udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all’art. 7 comma 2 ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all’art. 7 comma 3 determina l’estinzione del processo», anziché la cancellazione della causa dal ruolo. In particolare, secondo i giudici milanesi, il decreto delegato prevede che l’istanza di fissazione d’udienza debba essere notificata entro un termine perentorio che decorre da momenti diversi, a seconda di come in concreto si è svolto il contraddittorio, momenti la cui individuazione spetta alle parti alla luce di disposizioni normative di particolare complessità, frutto di una formulazione non sempre chiara e lineare. L’estinzione immediata nell’ipotesi de qua è apparsa, a tali giudici, conseguenza irragionevole, «avuto riguardo alla finalità dell’istituto dell’“estinzione”», sotto un duplice profilo: «in riferimento all’art. 3 della Costituzione, perché crea una diversità di trattamento essenziale, e non giustificabile tra il “non agire” costituito dal non comparire davanti al Collegio all’udienza ex art. 16 (sanzionato con la sola cancellazione della causa dal ruolo, benché imputabile ad entrambe le parti e, quindi, anche perciò sintomatico in modo ben più chiaro e biunivoco del disinteresse per la pronuncia giurisdizionale), e il “non agire” costituito dalla mancata notifica dell’istanza di fissazione d’udienza ex art. 12 nel termine di venti giorni dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 8, o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all’art. 7 comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui [continua ..]
L’art. 8, 4° comma, dispone che il processo si estingue se l’istanza di fissazione dell’udienza non sia stata notificata nei termini prescritti dallo stesso art. 8, ma non specifica se tale onere sussista anche nei confronti del convenuto rimasto contumace. La questione, già esaminata dai giudici di merito [45], merita alcune osservazioni. Per il combinato disposto dei commi 4° e 1°, lett. a), dell’art. 8, d.leg. n. 5/2003, il processo si estingue in ogni caso se l’attore ha omesso di notificare l’istanza di fissazione dell’udienza nei venti giorni successivi alla scadenza degli ulteriori venti giorni che decorrono dalla notifica della comparsa di risposta ovvero dalla scadenza del relativo termine (v. supra, § 5). L’estinzione, dunque, sembra prescindere dalla notificazione della comparsa di risposta ad opera del convenuto, potendo verificarsi anche se quest’ultimo non vi abbia provveduto (la c.d. contumacia «societaria» o «speciale» del convenuto si collega, infatti, alla mancata o tardiva notificazione della comparsa di risposta, a prescindere dalla costituzione in giudizio intesa in senso tecnico che, a norma dell’art. 5, avviene mediante deposito in cancelleria del fascicolo contenente l’originale ovvero la copia della comparsa di risposta notificata all’attore) [46]. Come è noto, per effetto della disciplina generale dettata dall’art. 292 c.p.c. gli atti da notificare al contumace sono quelli tassativamente indicati (sul punto v. infra, § 11). Ora, se da un canto, la disciplina speciale di cui all’art. 13, 2° comma, d.leg. n. 5/2003 [47], dispone che l’attore deve notificare, in ogni caso, l’istanza di fissazione d’udienza al convenuto rimasto contumace, dall’altro, l’inottemperanza a tale dovere non trova qui una diretta sanzione (l’art. 13, 2° comma, infatti, si limita a stabilire che, nella contumacia del convenuto, l’attore sceglie se notificargli una nuova memoria di replica a norma dell’art. 6 oppure se notificargli e depositare l’istanza di fissazione dell’udienza). Ne consegue che, in tali casi, benché il convenuto non si sia costituito secondo quanto previsto dall’art. 13, 2° comma, il verificarsi delle condizioni di cui al combinato disposto del 4° comma e del 1° [continua ..]
Ai sensi dell’art. 9 del decreto delegato, «la parte è tenuta al deposito in cancelleria dell’istanza di fissazione di udienza nel termine perentorio di dieci giorni dall’ultima notificazione» [48]. Il legislatore non ricollega, però, espressamente, un caso di estinzione del processo. Ciò nonostante, si è rilevato che anche il tardivo deposito della istanza, alla stregua della tardiva notifica della stessa, sia causa di estinzione e che, anche in questa ipotesi, il giudice debba provvedere a dichiararla secondo quanto disposto dagli art. 8, 4° comma e 12, 5° comma: e ciò sul presupposto che il deposito dell’istanza consente al giudice di conoscere della lite [49]. In effetti, la sanzione per il mancato deposito è quanto ci si dovrebbe aspettare al cospetto della disciplina dettata dall’art. 12, per cui il procedimento viene avviato «decorsi dieci giorni dal deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza», e non dalla notifica di questa [50]. Anche al solo fine di dichiarare l’estinzione, in applicazione dell’art. 12, 5° comma, è comunque necessario che il procedimento prosegua nei modi e nelle forme previste dall’art. 12, 1° e 2° comma; ciò che, inevitabilmente, è impedito dal mancato deposito dell’istanza, pur notificata. Ora, senza dubbio, la parte che ha provveduto a notificare l’istanza, ma che non ha rispettato il termine per il deposito, decade dalla facoltà di chiedere la fissazione dell’udienza. D’altro canto, però, l’idea di ritenere che il mancato deposito dell’istanza sia sempre causa di estinzione del processo non è del tutto persuasiva [51]. L’estinzione potrebbe, infatti, opportunamente verificarsi nell’ipotesi in cui sia l’attore che, pur avendo ritualmente notificato l’istanza, non provvede al deposito della stessa: benché il giudice non possa rilevarla d’ufficio, il convenuto, privo di qualsivoglia interesse a proseguire il processo, ne solleva l’eccezione. Al contrario, invece, se le altre parti a cui è stata notificata l’istanza sono interessate alla prosecuzione del processo, la sanzione dell’estinzione rischia di risultare del tutto inadeguata: in tali casi, invero, non è dato escludere che quelle stesse parti [continua ..]
Può accadere che, in mancanza di una esplicita dichiarazione di estinzione del precedente processo, la parte interessata riproponga la domanda [54]. Anche nel processo commerciale, si deve ritenere che il giudice successivamente adito non sia competente a decidere principaliter della questione relativa alla estinzione di un diverso processo, perché la disciplina comune di cui all’art. 39 c.p.c. impone al secondo giudice di spogliarsi della causa quando il primo processo non sia definito con una formale dichiarazione di estinzione, potendo al più ammetterne una cognizione soltanto incidenter tantum [55]. In altre parole, la riproposizione della medesima azione, fondandosi sull’ammesso riconoscimento della già verificatasi estinzione del primo processo, ne può comportare l’implicita richiesta di accertamento incidentale. Cosicché, in deroga al generale meccanismo per cui l’estinzione si verifica soltanto laddove la parte interessata ne sollevi tempestivamente l’eccezione, il giudice, successivamente adito, pur rilevando l’identità di parti, di petitum e di causa petendi (ovvero la continenza o la connessione di cause), deve astenersi dal dichiarare la litispendenza (la continenza o la connessione) potendo accertare, in via meramente incidentale, anche d’ufficio (rectius, in mancanza di una eccezione esplicita), l’avvenuta estinzione del processo precedentemente iniziato, ma, di fatto estinto, al limitato fine di invocarne gli effetti. Quanto rilevato presuppone però l’instaurazione di un nuovo processo. Invece, al solo fine di ottenere un provvedimento dichiarativo dell’estinzione, efficace nell’ambito del medesimo processo pur validamente instaurato ed estinto solo di fatto, la parte interessata può proporre istanza di fissazione d’udienza. Deve, a tal proposito condividersi l’opinione di chi ha ritenuto che, se l’estinzione è fatta valere ope actionis [56] ovvero, se l’istanza di fissazione di udienza è proposta, nel medesimo processo, al fine di farne dichiarare l’estinzione, l’organo giudiziario competente sia in ogni caso il giudice relatore e non il collegio [57]. L’ipotesi, in concreto realizzabile, non pare, infatti, sfuggire alla diretta applicazione della speciale disciplina [continua ..]
In linea con la regola comune secondo la quale la costituzione tempestiva di una delle parti consente all’altra di costituirsi anche successivamente (art. 171, 2° comma, c.p.c.), l’art. 13, 1° comma, del decreto delegato, attribuisce al convenuto, ritualmente costituito, la facoltà di dare impulso al processo a norma dell’art. 4, 2° comma, nonostante la mancata (o tardiva) costituzione dell’attore [58]. Sennonché, nella contumacia dell’attore [59], il convenuto, tempestivamente costituitosi, può scegliere di eccepire, nella comparsa di risposta, l’estinzione del processo. Anche nel processo ordinario, la mancata costituzione dell’attore può dar luogo all’estinzione ma, a tale esito, si perviene soltanto dopo [60] che il giudice istruttore lo abbia dichiarato contumace (allorché quest’ultimo abbia omesso di costituirsi anche alla prima udienza: art. 171, 3° comma, c.p.c.) e il convenuto non abbia espressamente chiesto la prosecuzione del giudizio (art. 290 c.p.c.); la causa è cancellata dal ruolo e il processo si estingue. Per il processo commerciale, il legislatore delegato ha previsto, invece, che, a seguito della mancata costituzione in giudizio dell’attore, la fattispecie estintiva si perfezioni in una fase che precede l’udienza [61] e che, a tal fine, non sia necessaria la dichiarazione giudiziale che certifichi la contumacia. Tale diversa disciplina induce a ritenere che l’evento individuato nella mancata costituzione dell’attore «nel termine previsto dall’art. 3» possa riferirsi anche alla costituzione tardiva dello stesso [62]. Peraltro, in tale ultima ipotesi, non può escludersi che, pur sollevata la questione relativa alla estinzione ad opera del convenuto, l’attore chieda di essere rimesso in termini ex art. 13, 5° comma (tale disposizione è prevista per le ipotesi in cui la parte abbia risentito pregiudizio nel proprio diritto di difesa a causa di irregolarità procedimentali); si tratterebbe, a ben vedere, del medesimo caso, previsto dalla disciplina comune (art. 294, 1° comma, c.p.c.), in cui il contumace, tardivamente costituitosi, chiede al giudice di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la costituzione è stata impedita da causa a sé [continua ..]
La fattispecie estintiva individuata dall’art. 13, 1° comma, rileva nel processo soltanto se l’attore non si è costituito nei termini e il convenuto che si costituisce tempestivamente in giudizio, sollevi l’eccezione. Tutt’altra situazione si verifica qualora nessuna delle parti si sia costituita nei termini previsti. Il 3° comma dell’art. 13 dispone che una di esse si può costituire anche tardivamente e proporre l’istanza di fissazione dell’udienza mediante deposito in cancelleria; in tali casi, «dell’avvenuto deposito dell’istanza deve essere data notizia mediante atto notificato alle altre parti, le quali possono costituirsi nei dieci giorni successivi…». Solo se l’altra o le altre parti non si costituiscono, trovano applicazione i commi 1° e 2°. La tempestività della costituzione in giudizio del convenuto, presupposta al 1° comma, ai fini dell’estinzione, perde, dunque, l’essenza di requisito necessario al 3° comma. Infatti, la norma non prevede soltanto la prosecuzione del processo, allorché una delle parti, benché costituitasi tardivamente, proponga istanza di fissazione d’udienza e le altre si costituiscano nei dieci giorni successivi, depositando i propri scritti difensivi, i documenti offerti in comunicazione e la nota contenente la formulazione delle rispettive conclusioni [73]; ma, consente altresì al convenuto, pur tardivamente costituito, di sollevare l’eccezione di estinzione del processo e, a all’uopo, di depositare l’istanza di fissazione dell’udienza, se l’attore non si costituisce nei dieci giorni successivi. Il difetto di coordinamento tra le due disposizioni in esame diventa, peraltro, palese per effetto dell’espresso rinvio nel 3° comma alla disciplina di cui al 1° comma [74]. Ci si chiede se la proposizione dell’istanza presuppone che le parti abbiano provveduto allo scambio degli atti difensivi. L’attore deve aver provveduto a notificare l’atto di citazione; il convenuto, oltre a non essersi ritualmente costituito, può non aver notificato la comparsa di risposta: si può verificare che l’attore, costituitosi tardivamente, propone istanza di fissazione d’udienza. Ma le perplessità investono, poi, anche i successivi atti. La notificazione, ovvero la scadenza dei [continua ..]
Mentre l’art. 13, 3° comma disciplina l’ipotesi in cui nessuna delle parti si sia costituita e non sia comparsa all’udienza, l’art. 16, 1° comma regola la diversa ipotesi in cui nessuna delle parti, pur costituite, compare all’udienza; tale evento produce la cancellazione della causa dal ruolo [79]. Proprio la particolare struttura del rito societario ha imposto al legislatore delegato una disciplina che si discostasse dall’art. 181 c.p.c. per il quale «se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo» [80]: probabilmente, infatti, lo sdoppiamento dell’udienza previsto non era parso coerente con il sistema processuale dell’udienza (tendenzialmente) unica previsto dall’art. 16. Sennonché, l’isolato riferimento alla cancellazione della causa dal ruolo [81] lascia presumere che, perfezionatasi la fattispecie estintiva de qua (pur con modalità diverse rispetto a quanto previsto dall’art. 181 c.p.c.), il procedimento previsto dall’art. 307, comma 1°, 2° e 4°, c.p.c. sia un percorso obbligato: a seguito della cancellazione della causa, le parti devono provvedere a riassumerla entro un anno; in mancanza, il processo si estingue [82] e, in ogni caso, la parte interessata all’estinzione dovrà provvedere a riassumere la causa al solo fine di ottenere una pronuncia in tal senso [83]. Il legislatore delegato tace, tuttavia, sulle forme necessarie a riassumere la causa cancellata dal ruolo. Innanzitutto, occorre precisare che l’evento sanzionato dall’art. 16, 1° comma presuppone conclusa la fase processuale dedicata allo scambio degli atti difensivi: le parti (una o entrambe, nell’ipotesi di istanza congiunta ex art. 11) hanno chiesto la fissazione dell’udienza, il giudice con decreto vi ha provveduto, ma la stessa udienza non si è svolta regolarmente a causa della mancata comparizione delle parti costituite. A questo punto, è ragionevole ritenere che, cancellata la causa dal ruolo, la riassunzione potrà avvenire per mezzo di una nuova istanza per un’udienza [continua ..]
L’art. 22 del decreto delegato, per il quale «se nessuna delle parti compare all’udienza, la corte d’appello ordina la cancellazione della causa dal ruolo», riproduce sostanzialmente l’art. 16, 1° comma, fatto salvo l’omesso riferimento alla costituzione in giudizio. Orbene, però, tale omissione non può certamente far presumere che il legislatore abbia intenzionalmente previsto la cancellazione della causa dal ruolo in appello ogniqualvolta le parti non siano comparse all’udienza e ciò, indipendentemente dalla loro costituzione; la circostanza per la quale è stata già fissata l’udienza di comparizione innanzi al collegio, infatti, impone di ritenere che almeno una di esse si sia costituita in giudizio [88]. Ora, nel giudizio di appello, la mancata costituzione di una ovvero di entrambe le parti produce diverse ed ulteriori situazioni processuali. La prima si verifica allorché l’appellante non si costituisca nel termine prescritto e l’appellato, invece, vi provveda tempestivamente; ai sensi dell’art. 20, 3° comma, su istanza di quest’ultimo, l’appello è dichiarato improcedibile [89]. Nulla si dice però del caso in cui l’appellante abbia omesso di costituirsi in termini e, d’altro canto, neppure l’altra parte, pur tempestivamente costituita, sia, però, comparsa. La dichiarazione di improcedibilità dell’appello dovrebbe rendere irrilevante il provvedimento ulteriore che prenda atto della mancata comparizione all’udienza. L’art. 20, 3° comma, tuttavia, consente al solo appellato che si sia costituito tempestivamente di sollevare l’eccezione di improcedibilità. Sicché, nel caso in cui l’appellato si sia costituito tardivamente e entrambe le parti abbiano omesso di comparire all’udienza, non v’è ragione per escludere che la causa debba essere cancellata dal ruolo per effetto dell’art. 22. La seconda situazione può concretarsi quando non si costituisce l’appellato e, in virtù del rinvio alla disciplina comune (art. 20, 2° comma), il collegio, verificata la regolarità della notificazione dell’atto di citazione alla prima udienza di trattazione (art. 350, 2° comma, c.p.c.), ne dichiari la contumacia. Anche in tale ipotesi, benché [continua ..]
Il processo commerciale si estingue altresì per cause di inattività diverse da quelle espressamente previste dal decreto delegato. Si tratta ora di verificare la compatibilità delle fattispecie estintive annoverate dall’art. 307 c.p.c. con il sistema processuale introdotto. Alcune di queste, come si è già osservato, sono assoggettate ad una disciplina in tutto o in parte diversa, dettata dallo stesso decreto. Con riguardo alle altre, invece, vi sono casi, previsti dalla legge comune, in cui il giudice ordina solo la cancellazione della causa dal ruolo, come, ad esempio, la mancata ottemperanza all’ordine del giudice per la chiamata del terzo ex art. 270 c.p.c., salva la possibilità della riassunzione entro un anno. Ora, se prodotte nell’ambito del processo commerciale, tali cause di inattività in parte soggiacciono alla disciplina comune. Tuttavia, al fine di individuare l’atto idoneo alla riassunzione della causa eventualmente cancellata dal ruolo del giudice competente (giudice relatore o collegio) nonché il procedimento per mezzo del quale il giudice possa provvedere sulla questione relativa all’estinzione, occorrerà di volta in volta, verificare il momento in cui l’evento effettivamente si produce nel processo. A norma dell’art. 307, 3° comma, c.p.c., il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetti di rinnovare la citazione [93] o di proseguire, riassumere [94] o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto nel termine stabilito. L’inottemperanza all’ordine impartito produce la fattispecie estintiva che, se rilevata in un momento che precede l’udienza, appartiene alla cognizione del giudice relatore, chiamato a provvedervi a norma dell’art. 12, 5° comma. Diversamente, se la questione viene sollevata all’udienza, la competenza è del giudice collegiale [95]. I casi di estinzione c.d. immediata previsti dal codice di rito non sono ipotizzabili in questo processo. Quanto alla mancata comparizione all’udienza dell’attore, nell’ipotesi in cui il convenuto non chieda di procedere in assenza di lui (art. 181, 2° comma, c.p.c.), il sistema processuale ad udienza (tendenzialmente) unica da un lato e l’art. 16, 1° comma dall’altro, sembrano escludere il rinvio della causa ad un’udienza [continua ..]
Il decreto delegato non prevede una espressa disciplina per le ipotesi in cui il processo si estingua per rinuncia agli atti. Sicché, nelle ipotesi in cui l’attore non abbia più interesse alla prosecuzione del processo diventa mutuabile il meccanismo previsto dall’art. 306 c.p.c., ai sensi del quale: «il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione (…). Il giudice se la rinuncia e la accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo» [96]. Le diverse fattispecie estintive individuate dal legislatore hanno indotto alcuni studiosi ad escludere l’applicabilità della disciplina prevista per la dichiarazione di estinzione in caso di inattività delle parti (art. 307, 4° comma, c.p.c.) alla rinuncia agli atti del processo: si è detto, infatti, che, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, il giudice dichiara l’estinzione con ordinanza e, soltanto in caso di contestazione sulla dichiarazione di rinuncia e della accettazione, provvede con sentenza [97]. Sennonché, in assenza di uno speciale regime, nulla impone che le forme processuali per la definizione della questione relativa alla estinzione «debbano essere diverse a seconda della causa da cui deriva» [98]. L’eventualità che il processo si estingua per rinuncia agli atti ovvero per inattività delle parti rileva, infatti, ai fini del contenuto del provvedimento giudiziale, non anche per la forma dello stesso [99]. Peraltro, se le forme predeterminate dal legislatore per la dichiarazione di estinzione per inattività delle parti caratterizzano legittimamente anche il provvedimento che chiude il processo per rinuncia agli atti, non altrettanto può dirsi per la disciplina dettata dall’art. 307, 4° comma, c.p.c., in tema di eccezione di estinzione [100]. È opinione pressoché pacifica che, se una delle parti rinunci agli atti del processo e le altre ritualmente accettino, a nulla rileva eccepire l’estinzione [101]. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione [102] sono rese nelle forme previste dall’art. 306, 2° comma, c.p.c., direttamente «dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e [continua ..]