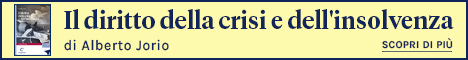
Articoli Correlati: nozione - partecipazioni societarie - disciplina - patti famiglia
1. Investimento e partecipazione: gli obiettivi del patto di famiglia - 2. (Segue). StabilitÓ dell'impresa e trasferimento di quote marginali; critica alla tesi estensiva; necessitÓ di individuare un criterio discretivo tra le molteplici forme partecipative - 3. La selezione in base al contenuto: poteri di ingerenza forte, di ingerenza debole e poteri di controllo - 4. (Segue). Strumenti finanziari partecipativi e patti di famiglia - 5. La selezione in base alle dimensioni della quota: maggioranza e minoranza, controllo e cogestione - 6. Controllo di diritto e controllo di fatto. EffettivitÓ e potenzialitÓ dell'esercizio del cogoverno - 7. Potere di cogestione e potere di blocco - 8. Controllo sull'impresa e patti parasociali - 9. Trasferimento parziale, trasferimento integrativo e trasferimento di diritti reali limitati - 10. Osservazioni conclusive - NOTE
La disciplina recentemente dedicata ai patti di famiglia si limita ad indicare, quali loro possibile oggetto, le «partecipazioni societarie» («quote») del disponente. Il riferimento è certo più anodino rispetto all’altro, quello all’«azienda», la cui connotazione quale entità funzionale all’esercizio dell’attività economica è consustanziale, sicché la destinazione del patto traslativo della stessa al perseguimento degli obiettivi di stabilità dell’impresa nella complessa fase del passaggio generazionale costituisce un dato evidente e ineludibile della fattispecie. D’altra parte, la stessa figura generale della cessione d’azienda (art. 2556 ss. c.c.) si delinea, nella ricezione e nella regolamentazione normative, come fattispecie contrattuale tipicamente preordinata all’avvicendamento nell’esercizio dell’attività, il cui nucleo traslativo viene per tale ragione arricchito ex lege attraverso la produzione di effetti specifici (artt. 2557 ss. c.c.), miranti ad assicurare nella sua pienezza la realizzazione dell’obiettivo causalmente connotante il negozio [[1]]. Non è di per sé così, diversamente, quando si trasmettano quote societarie, la cui valenza, sotto il profilo della effettiva strumentalità alla conduzione di iniziative economiche, è tutt’altro che unitaria, stanti i variabili diritti e le variabili prerogative che, per dimensione e contenuto, la partecipazione può in concreto conferire al suo titolare, rispetto al governo dell’attività comune. Il bene «quota» (o «azione») può rappresentare senz’altro il medium giuridico per l’esercizio di una signoria sull’impresa, ma può configurarsi altresì, di diritto o di fatto, come puro e semplice strumento di investimento, cui rimane estraneo qualsiasi significativo profilo di potere gestorio, sicché il suo trasferimento appare, dal punto di vista dei risultati conseguibili, assai più versatile rispetto a quello avente ad oggetto l’azienda. Per tale ragione, il relativo inquadramento nello speciale istituto dei patti di famiglia è sembrato immediatamente meno agevole e la nozione di «quota», come elemento patrimoniale il cui consolidamento in capo al discendente prescelto [continua ..]
Per la verità, la tesi stessa della necessità che la partecipazione risulti in qualche modo qualificata non dimora incontrastata fra i primi commentatori [[7]], ancorché appaia senza dubbio già oggi dominante e sia accolta sostanzialmente senza esclusioni dalla dottrina civilistica più autorevole. Al di là dell’argomento testuale (l’assenza di puntualizzazioni nell’art. 768-bis) [[8]], evidentemente poco meno che irrilevante, la soluzione estensiva muove fondamentalmente da una valutazione delle finalità perseguite dalla disciplina, maggiormente elastica rispetto a quella surriferita, sebbene essa stessa attenta alle ragioni dell’impresa: la continuità e la stabilità di quest’ultima, si assume, potrebbe essere pregiudicata non solo dalla conflittualità sorta tra i successori del socio di controllo e dal forzato ingresso nel governo dell’ente di soggetti inidonei o perseguenti fini personali, ma anche dalla frammentazione di una quota minoritaria e dal potenziale disinteresse di alcuno degli aventi diritto, rispetto all’investimento, vuoi perché comunque ciò potrebbe avere ricadute sugli equilibri gestionali, vuoi perché potrebbe portare – compatibilmente con le regole del tipo societario – ad un disimpegno anche monetario dall’attività, con conseguenze negative sulle dimensioni della realtà produttiva [[9]]. L’argomento è serio, ma non persuasivo, specie se riferito alle partecipazioni marginali, aventi per ciò stesso valenza esclusivamente finanziaria, soprattutto nelle grandi organizzazioni capitalistiche, che restano insensibili all’atteggiamento ed alle scelte di risparmio del singolo, piccolo investitore. D’altra parte pare eccessivo ascrivere al nuovo istituto una finalità così lata e, per certi aspetti, di veramente modesto significato; nelle stesse società di più piccole proporzioni, la circostanza che la conflittualità fra legittimari ed eredi designati di una partecipazione di minoranza, cui non è ricollegata alcuna influenza sull’impresa, possa rivolgersi in danno di quest’ultima appare scarsamente rilevante; ed eventuali abusi dei diritti corporativi, piegati al soddisfacimento di interessi successori, potranno essere sanzionati altrimenti, invocando i rimedi generali o [continua ..]
In questa prospettiva, una prima selezione tra le variabili forme di compartecipazione, in senso ampio, all’attività collettiva può delinearsi innanzitutto a livello dell’intensità che può avere, in ragione dei diritti che afferiscono alla quota, l’ingerenza sulla gestione imprenditoriale da parte del relativo titolare. Ora, il potere del socio di concorrere alla conduzione dell’impresa può concernere senz’altro il governo della stessa nel suo complesso: indirettamente, attraverso l’espressione del voto nella nomina degli amministratori da parte dell’assemblea di società per azioni (che la partecipazione azionaria, pur non espressamente menzionata, possa essere in linea di principio trasferita mediante patto di famiglia è sicuro [[12]]), o nelle procedure non assembleari di formazione delle decisioni, nella società a responsabilità limitata; e, ancora, attraverso il diritto di designazione degli stessi amministratori, accordato al titolare della quota di s.r.l. ex art. 2468, 3° comma, c.c. e variamente modulabile [[13]]; oppure direttamente, attraverso il potere stesso di gestione, conferito nuovamente al socio di s.r.l., o a quello di società di persone. L’ingerenza nell’attività può peraltro esplicarsi anche in forme assai più deboli: è il caso, principalmente, del diritto di esprimere pareri non vincolanti, ancorché obbligatori, che può spettare, su talune operazioni, agli accomandanti nelle società in accomandita di persone [[14]], ma che può inerire anche ad una categoria di azioni altrimenti prive del diritto di voto o a singoli soci di s.r.l., pur sempre come diritto particolare in ambito gestorio, conferito in via statutaria giusta la citata disposizione contenuta nell’art. 2468. Anche forme per così dire intermedie di influenza sono parimenti immaginabili. Principalmente, esse sono ricollegabili alla pertinenza del diritto di voto in ordine a specifiche decisioni strutturali concernenti l’impresa (modificazioni dell’oggetto sociale, in primis), o comunque riguardanti la sua conduzione, quando, corrispondentemente, manchi il potere di concorrere alla nomina degli amministratori: situazioni che possono profilarsi nelle s.p.a., in capo all’azionista a voto limitato, o nelle s.r.l., quando, pur essendo riservata [continua ..]
Il risultato testé raggiunto consente sin da subito di escludere dall’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto l’intero spettro delle forme partecipative ibride, introdotte nel modello finanziario della società per azioni dalla recente riforma del 2003. È pur vero che agli strumenti finanziari, emessi ai sensi dell’art. 2346, ultimo comma, c.c., possono essere conferiti significativi poteri di voice, ma, a ben vedere, nessuno di essi può nella sostanza spingersi, dal punto di vista funzionale, oltre la soglia della difesa dell’investimento. Si possono per evidenti ragioni qui tralasciare tutte le prerogative di controllo e di informazione, variamente modulabili e senz’altro accordabili ai titolari di tali rapporti partecipativi: diritti di consultazione della documentazione sociale, di raccolta di notizie da parte degli amministratori circa l’andamento dell’impresa, direttamente o in sede di assemblea speciale, oppure, ancora, attraverso il rappresentante comune, e via elencando. I diritti potenzialmente rilevanti, nella fattispecie, sarebbero rappresentati invece da quello di voto, conferibile su particolari argomenti di competenza dell’assemblea generale, e da quello di nomina di un componente dell’organo amministrativo o di controllo (art. 2351, ultimo comma, c.c.); poteri attraverso cui parrebbe delineabile una compartecipazione anche significativa dei terzi investitori nella gestione dell’attività collettiva. Va però considerato il fatto che, nonostante l’estrema sinteticità del dato normativo, risultano immanenti al quadro regolamentare alcuni stringenti vincoli di sistema, che precludono di estendere a piacere tali poteri e finiscono per funzionalizzarli eminentemente proprio a quella semplice preservazione delle posizioni individuali, che si contrappone idealmente al cogoverno vero e proprio ed esclude la trasferibilità del relativo rapporto per la via del patto di famiglia. Invero, è implicito nel riconoscimento della facoltà di attribuzione del diritto di voto un limite posto a presidio della posizione di signoria sull’iniziativa comune, propria degli azionisti, e di cui gli stessi non possono essere privati spostando il baricentro del potere decisionale verso le altre categorie di investitori: detto limite opera, per quel che qui interessa, sul piano oggettivo, rendendo necessario che gli [continua ..]
È intuitivo che, all’interno della categoria delle partecipazioni potenzialmente rilevanti, identificata in base al contenuto dei diritti inerentivi, si rende necessario procedere ad una ulteriore selezione, in ragione delle dimensioni percentuali della partecipazione stessa, cioè alla luce dei rapporti di forza interni alla compagine sociale. È chiaro infatti che, in linea di principio, una quota minoritaria o addirittura marginale non esprime alcun reale governo sull’impresa e solo idealmente, o, meglio, astrattamente, può dirsi che il suo titolare partecipi, attraverso l’esercizio dei diritti corporativi che gli competono, alla sua conduzione; e poiché gli obiettivi perseguiti attraverso il patto di famiglia sono assai concreti, è evidente che non può prescindersi dalla considerazione della effettiva attitudine del trasferimento a contribuire alla loro realizzazione. Sennonché l’equazione «cessione della quota di controllo = stabilità dell’impresa» sconterebbe un inaccettabile semplicismo, alla luce delle molteplici, possibili varianti in cui il potere di gestione può, nei diversi modelli organizzativi, attuarsi; sicché, ancora una volta, ciascuna di queste varianti deve essere pesata autonomamente, secondo un criterio, imperniato sì sul ruolo del socio all’interno della società, e tuttavia di non agevole decifrazione. È certo che, là dove la signoria sull’impresa si esercita indirettamente, attraverso la nomina degli amministratori, va riconosciuta la rilevanza, innanzitutto, della quota che assicura al suo titolare il controllo di diritto sulla società: il pacchetto azionario di maggioranza (id est: tale da attribuire la maggioranza dei voti in sede di designazione dei candidati a comporre l’organo gestorio [[22]]) nella società per azioni; la quota di maggioranza, nella società a responsabilità limitata, o anche qualsiasi altra quota che assicuri al suo titolare, ex art. 2468, 3° comma, il potere di nomina [[23]], sottraendolo alla collettività dei soci (e sempre che, va da sé, tale potere sia trasmissibile [[24]]). Con riferimento alla società per azioni, va osservato che il controllo rilevante ai nostri fini risulta quello esplicabile sulla gestione dell’impresa, nei termini sopra indicati; il possibile [continua ..]
È agevole a questo punto comprendere come debba attribuirsi rilevanza anche alla quota cui sia ricollegabile una posizione di controllo di fatto sull’impresa [[33]], idonea, attraverso il suo trasferimento, ad assicurarne la continuità, secondo una valutazione prospetticamente ragionevole, ed ancorché non possa a rigore escludersi la precarietà del ruolo svolto dal socio, atteso che la sua posizione risulta, giuridicamente, minoritaria. Questa fattispecie coincide con quella del controllo interno di fatto in senso tecnico, come definita (per la verità ormai infelicemente) dall’art. 2359 c.c.: rappresentata dalla disponibilità di un numero di voti tale da poter esercitare un’influenza dominante nell’assemblea chiamata a designare i componenti degli organi sociali [[34]]. In qualche modo speculare a questo è il fenomeno del controllo solo potenziale sull’attività, che pure rileva ai nostri fini [[35]]. L’attualità e l’effettività dell’esercizio della signoria sull’ente non appaiono invero condizione di significatività della partecipazione, sì che il socio di maggioranza, pur di fatto estraneo alle sorti della società, può senz’altro accedere comunque al patto di famiglia; d’altra parte, lo stesso ricorso ad esso manifesta in qualche modo la sua volontà di riservare per il futuro (a sé e) al discendente prescelto la facoltà di assumere il concreto governo dell’impresa.
Le posizioni corporative rappresentative di un ruolo di controllo o quantomeno di compartecipazione attiva del socio alla gestione dell’iniziativa economica costituiscono senza dubbio quelle tipicamente qualificanti la quota, nel quadro della nuova figura negoziale che veniamo esaminando. Una diversa, ma non meno centrale forma di ingerenza sull’attività d’impresa è però non infrequentemente delineabile, specie nelle società di medio-piccole dimensioni: quella rappresentata dal potere di blocco, in senso ampio, della gestione. Paradigmatico è il caso della società costituita da due soci o da due gruppi di soci contrapposti, ciascuno titolare della metà del capitale e conseguentemente in condizione di paralizzarne sistematicamente il funzionamento. Non dissimile la posizione del socio di s.r.l. cui, ex art. 2468, 3° comma, siano conferiti poteri di veto, vuoi sulla nomina alle cariche sociali, vuoi sul compimento di uno spettro particolarmente ampio di operazioni gestorie; o quella del socio-amministratore di una società di persone o a responsabilità limitata che abbia optato per il regime di amministrazione congiuntiva all’unanimità. Le relative quote di partecipazione appaiono senza dubbio trasferibili mediante patto di famiglia, sempre a condizione, va da sé, che il potere di blocco acceda alle stesse e sia dunque trasmissibile al discendente. È pur vero che, per questa via, non si garantisce all’impresa, in concreto, alcuna continuità, ma la posizione del socio resta decisiva per le sue sorti e conseguentemente per la sua stabilità. Né sembra opportuno introdurre alcun tipo di distinzione tra le diverse fattispecie, come potrebbe essere quella fra i casi in cui al consenso del socio sia subordinata la stessa adozione di ogni decisione societaria (amministrazione congiuntiva all’unanimità), i casi in cui almeno il suo mancato dissenso sia essenziale per la designazione alle cariche sociali (sicché occorre raccogliere, sostanzialmente, la sua adesione sulle candidature e quindi, indirettamente, sulle strategie imprenditoriali), e le ipotesi infine in cui, per converso, egli non abbia in concreto alcun potere di indirizzo e sia esclusivamente in condizione di precludere il compimento di un, sia pur significativo numero di affari, sì che la sua prerogativa assume carattere [continua ..]
Si è talora affermato che il potere di controllo qualificante la quota potrebbe derivare anche da accordi parasociali, in quanto attribuiscano ad uno dei soci una posizione di primazia, nei confronti degli altri, in sé non consustanziale alla partecipazione dal medesimo posseduta [[36]]. L’assunto richiede evidentemente un approfondimento, attesi gli stringenti vincoli di durata posti dalla disciplina societaria ai patti a tempo determinato e l’indefettibile precarietà di quelli stipulati a tempo indeterminato. Che, in linea di principio, il governo sulla società assicurato dagli accordi parasociali rilevi in vista del trasferimento della quota via patto di famiglia non appare discutibile, a condizione che sia prevista una forma di subingresso automatico nel sindacato da parte dell’acquirente, o che al negozio successorio si colleghi una modifica del sindacato stesso, in modo da farvi subentrare il discendente prescelto in luogo dell’alienante; ancorché il piano di esecuzione dell’accordo tra i soci sia distinto da quello sociale e non comprometta in alcun modo il libero esercizio dei diritti corporativi, il comportamento del socio paciscente ne resta in concreto condizionato, sicché la valutazione sostanziale della sua posizione, richiesta dalla disciplina successoria in esame, orienta senz’altro verso l’apertura del nuovo istituto a tali fattispecie, in quanto ricorrano i presupposti, in termini di compartecipazione al governo dell’ente, che sono sin qui emersi. Rilevano, in primo luogo, i sindacati di voto a maggioranza, con riferimento alla quota del socio che, all’interno del patto, dispone della medesima; come anche quelli attraverso cui vengano concordate formule di cogestione sostanziale, secondo uno degli schemi sopra esaminati. Sennonché tali accordi, per assumere valore nella prospettiva del patto di famiglia, devono essere per definizione tra quelli diretti ad assicurare la stabilizzazione del governo societario; per i quali, com’è ben noto, almeno nel contesto delle società per azioni la nuova disciplina codicistica fissa in un arco temporale quinquennale il periodo massimo di validità, nel caso in cui vengano contratti a tempo determinato, o riconosce ad ogni partecipante il diritto di recesso ad nutum, in caso contrario (art. 2341-bis c.c.). Con riferimento ai primi, la modesta ampiezza temporale e la [continua ..]
Il perseguimento degli obiettivi tipici del patto di famiglia non richiede necessariamente il trasferimento della quota o del pacchetto azionario del disponente nella loro interezza, come d’altra parte è esplicitato a livello normativo nello stesso art. 768-bis. In limine delle riflessioni sin qui condotte, restano da considerare alcune specifiche ipotesi potenzialmente rilevanti nel quadro del trasferimento «concordato» di recente regolamentazione: in primis, proprio quella del trasferimento parziale della partecipazione, attraverso cui potrebbe realizzarsi un avvicendamento graduale tra il discendente prescelto e il disponente o attuarsi una redistribuzione del capitale societario tra i diversi legittimari, con l’individuazione del futuro familiare di riferimento ed il mantenimento di una residua quota in capo agli altri; ma anche quella del trasferimento di una partecipazione in sé marginale, tuttavia incrementativa della quota già posseduta dal cessionario; infine, l’ipotesi della costituzione, a favore del discendente, di diritti reali limitati sulla quota stessa. In tutte queste fattispecie, è intuitivo che il presupposto inespresso della qualificazione di quest’ultima sul piano endoorganizzativo rappresenta nuovamente l’elemento selettivo e il requisito indeclinabile nell’individuazione del possibile oggetto del patto di famiglia. Per quanto concerne il trasferimento non integrale, è chiaro, pur nella genericità del dato normativo, che anche la «parte» ceduta deve consentire al discendente designato di esprimere una posizione di controllo o di cogoverno dell’impresa, di entità equivalente a quelle sin qui considerate [[41]]. Diversamente, la cessione si configura come assegnazione di un cespite patrimoniale rappresentativo di una posizione di natura eminentemente finanziaria, non suscettibile di accedere all’istituto in esame. Parallelamente, anche la costituzione di un diritto reale limitato sulla quota riceve il medesimo trattamento. Attraverso la cessione della nuda proprietà sulla quota e la riserva a se stesso dell’usufrutto, il disponente prepara invero il ricambio generazionale a favore del discendente prescelto [[42]], pur mantenendo, per la durata della propria vita o per il tempo per cui è stabilito l’usufrutto, il governo dell’impresa, in particolare quando la pertinenza [continua ..]
Il quadro che si è venuto delineando consente di tracciare un perfetto parallelismo tra l’ipotesi del trasferimento della partecipazione e quella del trasferimento d’azienda, come tra quella della cessione parziale della prima e (di un ramo) della seconda [[45]]. Non c’è dubbio che la restrizione della fattispecie, attraverso l’inserimento di un requisito implicito di qualificazione della quota, solleva non trascurabili difficoltà applicative, nella misura in cui si ritenga superabile il dato formale dell’esistenza di una posizione di controllo di diritto sull’ente e si assuma la significatività di situazioni di signoria o di cogestione in fatto. Sennonché tali difficoltà non sembra possano neppure essere sovrastimate, se si tiene conto della circostanza che, di regola, al patto di famiglia si farà ricorso per quote di enti a ristretta compagine sociale, in cui i rapporti di forza tra i partecipanti risulteranno tendenzialmente definibili con una certa semplicità. D’altra parte, non può certo farsi carico al notaio di un controllo che penetri sin negli equilibri interni all’organizzazione, sì che, ferma restando l’indagine sulla pertinenza di prerogative di natura corporativa idonee ad assicurare in astratto una compartecipazione del disponente al governo dell’impresa nei termini sopra considerati, l’effettività di tale compartecipazione dovrà essere dichiarata dai paciscenti in sede di stipulazione del patto e su tale dichiarazione – a meno che non sia prima facie smentita dalle circostanze o dalla documentazione a disposizione del notaio – potrà fondarsi l’accordo. La corrispondenza a verità della stessa potrà certo essere revocata successivamente in dubbio, forse persino dagli stessi legittimari partecipanti – a meno di non pensare di poter invocare nei loro confronti i principi dell’exceptio doli e il divieto di venire contra factum proprium al fine di paralizzarne l’azione di nullità –, ma senz’altro da quelli acquisiti in epoca più tarda; l’inconveniente appare tuttavia relativamente modesto, tenuto conto della sua verosimile, estrema episodicità, e non tale, come si è osservato, da indurre ad accogliere, per evitarlo, interpretazioni asistematiche del nuovo istituto successorio.