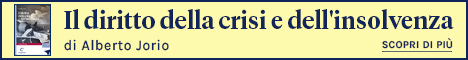
Articoli Correlati: eterodirezione - responsabilità - giurisprudenza - tribunale di milano - onere della prova - holding - responsabilità solidale
1. Premessa - 2. La recente giurisprudenza del tribunale di Milano - 3. Sulla legittimazione attiva della società eterodiretta ad agire ex art. 2497 c.c. contro la capogruppo - 4. Sulla natura dell’attività di direzione e coordinamento. I rapporti tra le società del gruppo e le inferenze sulla posizione degli organi gestori - 5. Azione ex art. 2497 c.c. e onere della prova - 6. Responsabilità da direzione e coordinamento di società e holding persona fisica - 7. Eterodirezione congiunta e responsabilità solidale ex art. 2497, 2° comma, c.c. Problemi e prospettive - NOTE
Negli ultimi due anni il tribunale di Milano si è pronunciato più volte su vicende (a torto o a ragione) ricondotte alla fattispecie di responsabilità tracciata dall’art. 2497 c.c. Una ricognizione delle decisioni rese in materia suggerisce l’opportunità di un’indagine volta a rilevare ed evidenziare le linee principali delle tesi interpretative che sembrano consolidarsi in seno alla giurisprudenza milanese. Come si vedrà di seguito, in una serie di pronunce – alcune delle quali rese, peraltro, in sede cautelare – il tribunale ha voluto trattare funditus della natura, dei presupposti, della portata e delle implicazioni della disciplina della responsabilità da eterodirezione di società, cogliendo l’occasione per prospettare le linee portanti del pensiero maturato sul tema, dopo una serie di sentenze tra loro diverse e già oggetto di analisi da parte della dottrina 1. D’appresso verranno riportati i passaggi fondamentali delle argomentazioni articolate in diritto nelle motivazioni dei provvedimenti esaminati (senza nessun riferimento al merito delle vicende concretamente dedotte in giudizio). All’esito verranno avanzate, in maniera trasversale e secondo l’ordine delle questioni emerse nelle pronunce, alcune considerazioni in merito all’assetto interpretativo che la giurisprudenza milanese va così adottando.
Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, 20 dicembre 2013 (ord.), n. 42294-1/2013 R.G. La pronuncia viene resa nell’ambito di un procedimento cautelare finalizzato ad ottenere un sequestro conservativo sui beni dei resistenti, già convenuti in responsabilità come soggetti (in ipotesi) esercenti l’attività congiunta di direzione e coordinamento sulle società ricorrenti/attrici [[2]]. Nel volgere all’analisi del fumus boni iuris a fondamento della richiesta tutela cautelare, il giudice rileva che il titolo di responsabilità ex art. 2497 c.c. azionato in giudizio introdurrebbe «varie questioni: a’) Sussistenza della legittimazione (attiva) della società eterodiretta ad agire in responsabilità nei confronti dell’ente/soggetto dirigente. a’’) Sussistenza della legittimazione (passiva) della persona fisica che abbia esercitato attività di direzione e coordinamento di una società ad essere destinataria di azione risarcitoria esercitata dalla società eterodiretta. a’’’) Puntualizzazioni sulla natura dell’attività di direzione e coordinamento. a’’’’) Configurabilità dell’esercizio congiunto dell’attività di direzione e coordinamento tra più soggetti. a’’’’’) Criteri di prova dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento. a’’’’’’) Puntualizzazioni sulla deduzione attorea». a’) Sussistenza della legittimazione (attiva) della società eterodiretta ad agire in responsabilità nei confronti dell’ente/soggetto dirigente. Nel così articolato ordo quaestionum, il tribunale affronta anzitutto uno degli aspetti più problematici posti dal rapporto tra il primo comma e il terzo comma dell’art. 2497 c.c.: quale sia, nella specie, la posizione delle società eterodiretta nell’ambito della dinamica delle responsabilità prevista dalla norma. E, al riguardo, il tribunale riconosce in maniera ferma “la legittimazione (attiva) della società eterodiretta ad agire in responsabilità nei confronti dell’ente/soggetto dirigente”. A fondamento del proprio convincimento, il giudice ritiene che convergano una pluralità di ragioni, sorrette da argomenti [continua ..]
Come già in parte evidenziato nel riportare i provvedimenti in analisi, i passaggi delle motivazioni delle prime due ordinanze cautelari affrontano profili delicati e particolarmente dibattuti della disciplina codicistica dettata in materia di direzione e coordinamento di società. E nell’alveo della ricostruzione da esse tracciata possono poi ricondursi, per quanto riguarda l’impostazione di fondo, anche le successive due sentenze di cui si è data notizia. Senz’altro meritevole di una sua autonoma considerazione è, invece, l’ultimo provvedimento trascritto, che, come le ordinanze di apertura, ha trattato funditus alcuni profili interpretativi relativi alla disciplina della responsabilità ex art. 2497 c.c.; profili, questi, sui quali è opportuno indugiare. I due “fronti interpretativi” – non in contrasto tra loro, ma sicuramente capaci di distinguersi l’uno dall’altro – prospettano una serie di riflessioni che paiono proporsi come ideali punti di maturazione degli orientamenti sul tema propri della sezione commerciale del tribunale ambrosiano. Le decisioni, cioè, più che come precedenti giurisprudenziali, aspirano a porsi quali veri e propri referenti di indirizzo in materia di direzione unitaria di società. Come anticipato, nella prima ordinanza cautelare il tribunale di Milano, dopo aver dichiarato la struttura dell’ordo quaestionum, che informa la motivazione del provvedimento, tratta della legittimazione attiva della società eterodiretta danneggiata ad esperire l’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. nei confronti del(dei) soggetto(i) che eserciti(no) l’attività di eterodirezione 4. La considerazione del fatto che le società eterodirette siano titolari dei patrimoni, in ipotesi, direttamente lesi dalla politica abusiva della holding e che esse si siano concretamente attivate per ottenere il risarcimento del danno (che sostengono di aver) subìto, porta il giudice investito del ricorso cautelare non solo a riconoscere la loro legittimazione ad agire 5; ma anche, più in generale, ad affrontare il rapporto tra le menzionate istanze risarcitorie e la disciplina dell’azione di responsabilità da eterodirezione ex art. 2497 c.c. Quest’ultima viene, in qualche modo, assimilata e ricondotta alla stessa natura delle prime (id est: [continua ..]
Tanto nei provvedimenti cautelari, quanto nella sentenza quivi riportati, il tribunale di Milano ha affermato la netta distinzione, concettuale e normativa, intercorrente tra attività di direzione e coordinamento e attività gestoria delle società controllate soggette alla direzione unitaria dell’ente di vertice. E in effetti – come indicato anche dall’uso di clausole generali diverse da quelle che connotano il mandato gestorio (art. 2392 c.c.) – l’attività di eterodirezione è (ulteriore nonché) differente 23 rispetto sia all’attività di gestione in senso stretto della holding sia a quella di realizzazione dell’oggetto sociale delle società controllate. Detta attività, per la holding, si concreta nella formulazione, nell’attuazione e nel controllo della propria politica imprenditoriale di direzione strategica e di coordinamento delle imprese delle società asservite; e per queste ultime, di conseguenza, rileva come ciò che detta la loro posizione nell’ambito del gruppo e, tramite questo, sul mercato 24. Per i soci esterni (e per i creditori) delle società eterodirette, invece, il rilievo che assume l’attività di direzione unitaria condotta dalla capogruppo è – e non può che essere – diverso, poiché essa investe dall’esterno le dinamiche di produzione dell’azione dell’ente partecipato (e debitore), incidendo sulle condizioni di rischio dell’investimento e, pertanto, sulla redditività e sul valore della partecipazione sociale (nonché, per i creditori, sul grado di attuabilità delle pretese obbligatorie sul patrimonio sociale debitorio). Ebbene, come già ricordato, la disciplina dell’art. 2497 c.c. è stata dettata avendo come campo di riferimento (di osservazione e di applicazione) la relazione tra eterodirezione (da un lato) e posizione dei soci esterni e dei creditori delle società a valle (dall’altro). Da questa specifica prospettiva, essa non tratta – quantomeno in via immediata – né (i) del fondamento e della portata del potere di eterodirezione, né, per altro verso, (ii) dei rapporti tra controllante e controllate e, segnatamente, dei rapporti tra i rispettivi organi gestori. Il rilievo parrebbe quasi scontato. Ma, in fondo, esso non è inutile, se si [continua ..]
Nel procedimento cautelare sopra riportato, le allegazioni fatte dalle parti ricorrenti a sostegno delle proprie pretese contemplavano censure specifiche in relazione ad operazioni ben individuate, ma il giudice, prima di esaminare in concreto le deduzioni attoree, ha inteso prospettare anzitutto la tesi interpretativa (ritenuta) più corretta in punto di ripartizione dell’onere della prova nei giudizi ex art. 2497 c.c. Anche nella sentenza del 14 novembre 2014 vi sono interessati osservazioni sul tema. E, più in generale, le riflessioni svolte dal tribunale investono un tema di importante rilievo teorico e di sicuro impatto pratico: il problema della prova nei giudizi di responsabilità occupa, infatti, un campo sul quale si gioca buona parte dell’effettività della tutela approntata dalla legge. Entrando gradatamente nel tema, può preliminarmente osservarsi che, ad una più ampia ricognizione delle decisioni rese dalla giurisprudenza di merito nelle liti ex art. 2497 c.c. avviate nei primi anni di vigenza dell’attuale normativa, l’impressione suscitata sia che i giudici abbiano agevolato l’esperimento, da parte dei “soci esterni” del gruppo, di iniziative giudiziarie dirette e immediate contro la holding, bypassando la scissione logico-temporale di attuazione della tutela tracciata dal combinato disposto dei commi terzo e primo dell’art. 2497 c.c. 35 e ritenendo, nella specie, che la disposizione del terzo comma potesse dirsi rispettata con una mera denuntiatio litis nei confronti della società partecipata e danneggiata (soluzione, questa, sposata anche dai provvedimenti in commento) 36. Tuttavia ciò è maturato in un contesto in cui le pretese dei tribunali in merito alle allegazioni e alle deduzioni dei mezzi prova attorei si sono spesso rivelate molto rigorose 37: sicché, in definitiva, alla maggiore immediatezza della vocatio in ius della holding da parte dei soci delle società eterodirette ha fatto da contraltare una strada tutta in salita per far valere con successo le ragioni dedotte in giudizio 38. L’attenzione della dottrina, a sua volta, è stata catturata innanzitutto dal tema della classificazione della fattispecie di responsabilità, dividendosi gli interpreti tra chi ne ha sostenuto la matrice aquiliana e chi invece ha inteso rinvenirvi gli estremi della responsabilità [continua ..]
La fattispecie concretamente portata a cognizione del giudice in sede cautelare, ha indotto il tribunale, tanto in prima istanza quanto nel giudizio di reclamo, a prendere posizione anche in merito all’applicazione della disciplina dettata dall’art. 2497 c.c. nei confronti dell’holding persona fisica. In linea di principio, e (anzi) tanto sotto il profilo normativo quanto in punto di ricognizione del diritto vivente, come lo stesso tribunale ha cura di evidenziare, non v’è dubbio che una persona fisica possa esercitare in maniera professionale e organizzata l’attività di direzione unitaria di più imprese societarie partecipate. Tuttavia, come è noto, le vicende che hanno interessato la redazione del testo dell’art. 2497 c.c. [[52]] hanno suscitato, all’indomani della riforma, il problema interpretativo dell’applicazione a detta ipotesi della disciplina della responsabilità dettata per «le società e gli enti»: la modifica testuale (da “chi” a “le società o gli enti”) è stata letta da parte della dottrina non solo nel suo risultato immediato di riferire la fattispecie alle società e agli enti esercenti l’attività di direzione unitaria; ma anche in quello ulteriore di escludere espressamente applicazioni analogiche e/o estensive della norma [[53]]. Nella decisione riportata, il tribunale ambrosiano avalla, invece, la sanzionabilità ex art. 2497 c.c. anche della holding persona fisica. I percorsi argomentativi a tal fine seguiti, prima dal giudice del ricorso cautelare e poi dal collegio in sede di reclamo, sono, in parte, diversi: il primo si fa carico di un più ampio ventaglio di considerazioni e di rilievi; il secondo è più selettivo e più netto. Le argomentazioni spese riproducono, in sostanza, i due crinali sui quali si sono progressivamente articolate le critiche levate in dottrina avverso il preteso esito dell’irresponsabilità ex art. 2497 c.c. della holding persona fisica. Orbene, senza indugiare su ipotesi di lettura che vorrebbero far rientrare la persona fisica capogruppo tra gli “enti” considerati dalla norma (ciò che equivale – in sostanza – a negare, invece che ad affrontare il problema interpretativo), fondamentalmente può dirsi che vi sia chi ha rilevato come una lettura [continua ..]
Sempre nella parte dedicata in generale alla disciplina dell’attività di direzione e coordinamento di società, il tribunale tratta due ulteriori profili meritevoli di riflessione: il problema della configurabilità dell’eterodirezione congiunta e di imputazione della correlata responsabilità; e il diverso tema della corresponsabilità ex art. 2497, 2° comma, c.c., con le conseguenti ricadute in punto di onere di allegazione e di prova, incombenti sull’attore che voglia citare in responsabilità più ipotetici compartecipi nell’abuso da direzione e coordinamento. Su altro piano, il tribunale si pronuncia anche sull’ammissibilità e sulla rilevanza diretta ai fini dell’applicazione della disciplina dell’attività congiunta di direzione e coordinamento 59. A tal fine, il giudice valorizza sia il dato testuale d’esordio dell’art. 2497 c.c. (che guarda alle società o enti), sia il profilo, per così dire, ontologico, per il quale se più soggetti hanno cagionato un danno, è naturale che la responsabilità si imputi a tutti gli agenti; sia ancora la riconosciuta ammissibilità del controllo congiunto, in merito al quale il tribunale non manca di dare alcuni referenti di emersione normativa (testuali i riferimenti al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e allo IAS 24). A ciò il giudice aggiunge che se il legislatore stesso, con l’art. 2497, 2° comma, c.c., ha inteso censurare tutti i compartecipi nell’abuso di eterodirezione, allora davvero non possono nutrirsi dubbi interpretativi sull’ammissibilità e sulla sanzionabilità dell’eterodirezione congiunta. Il tribunale, in ogni caso, non prende posizione sulle possibili modalità di svolgimento dell’attività congiunta di direzione e coordinamento; ma, poi, in un altro passo dell’ordinanza, distingue espressamente tale fattispecie dall’estensione di responsabilità di cui all’art. 2497, 2° comma, c.c. Per quanto riguarda il primo profilo, possono senz’altro richiamarsi le osservazioni della dottrina che, nell’analisi del fenomeno, ha distinto i due piani della disponibilità del potere e dell’attuazione dello stesso e, all’esito, evidenziato come l’attività di direzione e [continua ..]