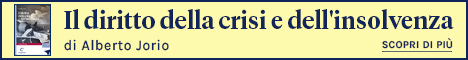
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, sez. fall., decr., 16 aprile 2014 – Savastano Presidente – Fanticini Est
Concordato preventivo con attribuzione di azioni – Fallimento del debitore – Possibilità per il creditore di insinuare il proprio credito al passivo del fallimento – Insussistenza
(Art. 160 legge fall.; art. 1197 c.c.)
Nel caso in cui venga risolto un concordato preventivo nel quale i creditori siano stati soddisfatti con attribuzione di azioni della società riorganizzata e venga successivamente dichiarato il fallimento del debitore, i creditori assegnatari di azioni non sono legittimati a insinuare il proprio credito al passivo del fallimento. Ciò perché dinanzi a operazioni sul capitale o straordinarie ad effetti “irreversibili” deliberate e attuate in sede concordataria, la risoluzione del concordato produce i soli effetti retroattivi che appaiono compatibili con la situazione derivante dalla riorganizzazione concordataria. Conseguentemente l’attribuzione – nel rispetto delle previsioni contenute nel piano – di diritti differenti da ordinari mezzi monetari con le forme della datio in solutum (art. 1197 c.c.) costituisce pieno adempimento ed integrale soddisfazione dei creditori inclusi nella classe per la quale si prevede tale metodo solutorio; il relativo effetto è quello di estinguere, con efficacia satisfattiva, l’originaria obbligazione concorsuale così come ristrutturata.
DECRETO
… Omissis …
– rilevato che l’opponente si duole dell’esclusione dal passivo fallimentare del credito chirografario di Euro 544.237,00, motivata dall’attribuzione all’odierna opponente – nell’ambito della proposta concordataria avanzata dalla società oggi fallita, approvata dai creditori, omologata e poi risolta ex art. 186 l. fall. – di azioni di Euro Casting s.p.a. (in particolare, il piano concordatario prevedeva il pagamento del 30% del credito maturato al 6 marzo 2009 in tre rate annuali di pari importo senza interessi e la conversione a capitale di rischio del 70% dei residui crediti chirografari, da impiegare per coprire le perdite e ricapitalizzare la società);
– rilevato che – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Fallimento opposto – non può ravvisarsi nell’accettazione della proposta concordataria una remissione del debito da parte del creditore per la quota del 70%, sia perché la proposta concordataria non è formulata in questi termini, sia perché la causa del negozio di concordato (Cass. sez. un. 1521/2013) poggia sul «superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato» e sull’«assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro», di talché non è interpretabile come remissione del debito la falcidia concordataria (né può logicamente ipotizzarsi una remissione come effetto del voto di maggioranza);
– rilevato, che sotto un profilo squisitamente civilistico, la risoluzione negoziale per inadempimento (fattispecie a cui può essere ricondotta anche la risoluzione ex art. 186 l. fall.) ha effetti retroattivi (ex tunc) tra le parti (art. 1458 c.c.) e ciò comporta il ripristino della situazione anteriore: in base a tali disposizioni, una volta risolto il concordato preventivo, i creditori (come l’odierna) potrebbero pretendere l’insinuazione al passivo fallimentare dell’originaria obbligazione (nella misura del 100% del credito chirografario);
– rilevato che il principio civilistico sopra esposto deve però essere calato in un contesto peculiare come quello fallimentare: da un lato, si è in passato ritenuto che la dichiarazione di fallimento successiva alla risoluzione del concordato «retroagisce al momento del decreto di apertura della procedura di concordato, e … determina, ovviamente, l’ammissione al passivo dei crediti anteriori per l’intero loro ammontare e non già nella misura “falcidiata” dal concordato» (Corte cost. 106/2004); dall’altro, si osserva (come fa la convenuta) che la disciplina fallimentare eccezionalmente consente ai creditori di mantenere le garanzie offerte in sede concordataria per le somme ancora dovute e di trattenere quanto già riscosso a norma dell’art. 140 l. fall. (norma che, seppur non richiamata dall’art. 186 l. fall., è stata ritenuta applicabile al caso della risoluzione del concordato preventivo da Cass. sez. un. 1482/1997 la quale, tuttavia, ragionava in termini di maggior tutela del ceto creditorio: «Se così non fosse, del resto, il concordato preventivo, da istituto concepito per prevenire il fallimento dell’impresa in crisi con un parziale, ma garantito, soddisfacimento delle ragioni creditorie, finirebbe per trasformarsi in un espediente per prorogare artificiosamente il dissesto in danno degli incolpevoli creditori: sui quali, infatti, se privati della garanzia prestata per l’attuazione del concordato, verrebbe spostato il rischio relativo all’inadempimento del debitore e alla conseguente risoluzione del concordato medesimo»);
– rilevato che, esaminando più specificamente il concordato preventivo di Euro Castings S.p.A., per addivenire alla corretta soluzione della questione occorre valutare la disciplina del “nuovo concordato”, come ridisegnato dalla riforma della legge fallimentare;
– rilevato che le innovazioni normative riguardanti le soluzioni concordatarie comprendono (tra l’altro) la possibilità di operazioni finanziarie, sul capitale e “straordinarie”, astrattamente utilizzabili come strumento di soluzione della crisi e/o dell’insolvenza; in particolare, sono oggi ammissibili interventi di ristrutturazione patrimoniale, finanziaria e societaria dell’impresa in crisi, che si estendono dalla rinegoziazione dei debiti – anche mediante emissione di obbligazioni (ordinarie o convertibili) e di altri strumenti finanziari – alla ricapitalizzazione della società ad opera dei soci e/o di terzi, alla conversione dei debiti in capitale mediante sottoscrizione riservata ai creditori (o a società da questi partecipate), alla fusione con altra società dotata di adeguati mezzi patrimoniali e finanziari, allo scorporo di azienda e alla scissione finalizzati alla costituzione di nuove società o al trasferimento delle attività e del patrimonio per gli scopi del concordato; deve pure reputarsi consentita la proposta di assegnazione ai creditori dei titoli rivenienti da siffatte operazioni “in luogo” del pagamento dei crediti (o di una parte dei loro crediti) e produrre con ciò un radicale mutamento degli “assetti imprenditoriali”;
– rilevato che, dunque, la riorganizzazione concordataria prefigura – almeno in potenza – l’integrale commutazione del patrimonio sociale, cioè delle attività e passività, e delle partecipazioni esistenti, in (nuove) partecipazioni e strumenti finanziari emessi dalla società risultante dal relativo processo, alle condizioni fissate dalla proposta di concordato (art. 160, comma 1, lett. a, l. fall.);
– rilevato che nella proposta concordataria de qua (approvata e omologata, poi risolta) i creditori concorsuali sono configurati come “assegnatari” delle azioni rivenienti da aumento del capitale, in conversione – forzosa – dei crediti vantati verso la società in crisi o insolvente: la copertura del nuovo capitale e il riassetto della “proprietà” derivano dalla omologazione stessa del concordato, a prescindere da qualsiasi dichiarazione di volontà negoziale e/o dall’esecuzione di nuovi apporti finanziari, da parte dei singoli destinatari: specificamente, la conversione forzosa di una parte dei debiti commerciali e/o finanziari della società in partecipazioni al capitale deve essere considerata alla stregua di una sottoscrizione ex lege, in virtù dell’efficacia vincolante del concordato ex art. 184 l. fall.;
– ritenuto che in tale contesto la mancata “attuazione” dell’operazione societaria deliberata nei termini fissati in funzione del contenuto della proposta di concordato possa integrare una causa “oggettiva” di risoluzione ai sensi dell’art. 186 l. fall. anche con effetti ex tunc e indipendentemente dal voto favorevole espresso dai creditori (il quale non può essere considerato come anticipata acquiescenza a un totale inadempimento);
– ritenuto che, però, qualora l’attribuzione del capitale di rischio (assegnato in soddisfazione del credito pecuniario originario) abbia trovato esecuzione, l’art. 186 l. fall. non possa determinare la caducazione automatica e retroattiva delle modifiche organizzative che sono destinate a dare vita ad una situazione nuova e spesso irreversibile (si pensi a operazioni di fusione/scissione), in considerazione dell’autonomia e della specialità della disciplina societaria (che regola la materia dell’invalidità delle deliberazioni favorendone la stabilità) e del principio generale di irrevocabilità delle deliberazioni già eseguite nei rapporti con terzi;
– ritenuto che, in altri termini, dinanzi a operazioni sul capitale o straordinarie ad effetti “irreversibili” deliberate e attuate in sede concordataria, non possa ammettersi la disapplicazione della disciplina societaria, ma, piuttosto, la produzione di quei soli effetti retroattivi della risoluzione ex art. 186 l. fall. che appaiono compatibili con la situazione derivante dalla riorganizzazione concordataria;
– ritenuto che, dunque, possa ricostruirsi la vicenda de qua in termini differenti rispetto alla “secca alternativa” (prospettata dagli odierni contendenti) tra una risoluzione con effetti ex tunc (che non coglie le caratteristiche di questo peculiare negozio concordatario) e una interpretazione in malam partem (per i creditori) dell’art. 140 l. fall. (del quale si offre una forzata lettura a contrario per arrivare a riconnettere un qualche effetto novativo alle obbligazioni sorte col concordato): per effetto del decreto di omologa ex art. 184 l. fall. al debitore è concessa la possibilità di liberarsi dall’obbligazione originaria (ristrutturata) mediante l’esecuzione di una prestazione diversa da quella originariamente convenuta (art. 1197 c.c.); l’estinzione dell’obbligazione è configurabile mediante l’attribuzione – nel rispetto delle previsioni contenute nel piano – di diritti differenti da ordinari mezzi monetari con le forme della datio in solutum (art. 1197 c.c.); trattandosi di “prestazione in luogo dell’adempimento”, l’attribuzione dei titoli è volta alla consegna di un determinato bene, ma non garantisce anche un risultato monetario finale; ciò sta a dire che la consegna da parte della società in concordato ai propri creditori delle azioni di nuova emissione costituisce pieno adempimento ed integrale soddisfazione dei creditori inclusi nella classe per la quale si prevede tale metodo solutorio; il relativo effetto è quello di estinguere, con efficacia satisfattiva, l’originaria obbligazione concorsuale così come ristrutturata (del resto, l’art. 160 l. fall. utilizzando l’espressione “soddisfazione mediante attribuzione”, anche sotto il profilo letterale, sembra richiamare la “prestazione in luogo dell’adempimento” e, soprattutto, l’effetto estintivo riconducibile a quest’ultima);
– ritenuto, quindi, che nelle riorganizzazioni societarie, anche in caso di risoluzione del concordato preventivo, una volta che il credito sia stato fatto oggetto di un mutamento qualitativo-quantitativo e di una nuova regolazione (a seguito di conversione in azioni, quote, obbligazioni ecc.), esso non potrebbe risorgere nella sua originaria consistenza, essendo irreversibile l’effetto pienamente “estintivo” della datio in solutum;
– rilevato che l’effetto solutorio tipico della datio in solutum discende non dalla mera consegna del titolo (modalità che, peraltro, sarebbe attuabile solo per i tipi sociali le cui partecipazioni sono incorporate in un titolo: dunque, non per le società a responsabilità limitata): l’effetto estintivo dell’obbligazione deriva, invece, dallo spiegamento dell’attività volta alla costituzione e assegnazione di una nuova partecipazione sociale in luogo del precedente rapporto obbligatorio (con l’iscrizione dell’aumento di capitale nel Registro delle Imprese e l’indicazione nominativa dei nuovi stakeholders – i creditori assegnatari – la datio deve ritenersi perfezionata, fermo restando il diritto degli azionisti di richiedere ed ottenere dall’organo amministrativo la consegna delle azioni “cartacee”);
– ritenuto che, dunque, essendo state assegnate all’odierna opponente le azioni di Euro Casting derivanti dalla conversione di una parte del suo credito chirografario (esecuzione della prestazione concordataria), la risoluzione del concordato preventivo non possa travolgere anche l’aumento di capitale e l’attribuzione delle partecipazioni, atto al quale, anzi, deve collegarsi l’estinzione dell’obbligazione (quantomeno con riguardo al 70% del credito chirografario);
– ritenuto che, perciò, l’esclusione dal passivo fallimentare sia stata correttamente disposta;
– ritenuto che possano compensarsi le spese di lite, in considerazione della difficoltà delle questioni e per l’oggettiva controvertibilità della soluzione qui adottata;
… Omissis …
Articoli Correlati: fallimento - debitore - insussistenza - concordato preventivo
1. Introduzione - 2. Il caso e la sentenza in commento - 3. La normativa di riferimento e gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza - 4. Il commento - 4.1. Sulla relazione fra la delibera di aumento del capitale sociale e la procedura di concordato preventivo: la proposta omologata come tecnica di sottoscrizione e liberazione delle azioni - 4.2. Sulla natura delloperazione di conversione dei crediti in capitale - 4.3. Sugli effetti della risoluzione del concordato preventivo con attribuzione di azioni - NOTE
Le riforme della legge fallimentare che si sono succedute dal 2005 a oggi hanno introdotto nell’ordinamento concorsuale italiano nuovi concetti che debbono ancora essere pienamente compresi e sistematicamente collocati. Il riferimento è alla terminologia (all’epoca) quasi rivoluzionaria impiegata dal legislatore: “ristrutturazione dei debiti”, “attribuzione ai creditori (...) di azioni”, “suddivisione dei creditori in classi” sono infatti concetti nuovi, talvolta importati da ordinamenti stranieri. Mentre l’uso di alcuni di questi istituti (si pensi alla classe dei creditori) è ormai acquisito nella prassi, quelli che consentono di effettuare operazioni sul capitale della società in crisi sono stati invece poco utilizzati, anche a causa del fatto che debbono ancora essere compresi appieno [1]. In questo contesto di bisogno di chiarezza si colloca la decisione del Tribunale di Reggio Emilia che si commenta. Una società aveva coraggiosamente utilizzato uno strumento, quello della “attribuzione ai creditori (...) di azioni” in via satisfattiva, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo che prevedeva la continuazione dell’attività d’impresa in capo allo stesso debitore. Ciò in un contesto che all’epoca non conosceva precedenti al riguardo e in assenza di un inquadramento sistematico dell’istituto da parte della dottrina. Risolto il concordato per inadempimento del debitore alle residue obbligazioni pecuniarie (quelle cioè non soddisfatte con l’attribuzione delle azioni), si sono poste una serie di questioni, che per la prima volta vengono dunque affrontate dalla giurisprudenza, la più rilevante delle quali attiene al trattamento, nel fallimento, del creditore che nel concordato risolto era stato soddisfatto mediante l’attribuzione delle azioni [2]. Il commento che segue sottoporrà a vaglio critico le conclusioni raggiunte dal tribunale di Reggio Emilia. Si precisa che le conclusioni che qui si espongono non sono destinate a mutare in conseguenza delle modifiche nel frattempo apportate alla legge fallimentare con l’importante d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. Tale riforma, tuttavia, può indirettamente incidere sul tema, facilitando la presentazione di proposte che prevedono [continua ..]
Nel caso deciso dal tribunale di Reggio Emilia, il debitore, una società a responsabilità limitata, aveva proposto ai propri creditori di soddisfare i loro crediti (anche) per mezzo della conversione dei crediti in azioni. La proposta si fondava su un piano che formalmente prevedeva il mantenimento della continuità aziendale in capo allo stesso soggetto che l’aveva esercitata fino alla data della procedura, ma sostanzialmente prevedeva l’integrale mutamento della compagine sociale. Ciò per effetto (a) della trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni, (b) dell’abbattimento delle perdite maturate per effetto della falcidia concordataria, e in particolare della rinuncia a parte del proprio credito da parte di taluni creditori, (c) di una riduzione del capitale sociale in conseguenza delle perdite residue, (d) di un successivo aumento del capitale, con esclusione del diritto di opzione, strumentale alla realizzazione di una conversione di altra parte dei crediti in azioni della società debitrice, ed (e) dell’attribuzione delle azioni ai creditori che avevano rinunciato a parte dei propri crediti. Una parte dell’indebitamento veniva mantenuto in capo alla società così ristrutturata e ricapitalizzata. Approvato e omologato il concordato preventivo, mentre l’operazione di conversione dei crediti in azioni veniva interamente eseguita, così come previsto nella proposta, la società debitrice rimaneva invece inadempiente ad altri debiti sopravvissuti alla falcidia concordataria. Il concordato veniva quindi risolto e la società dichiarata fallita. Uno dei creditori, il cui credito era stato (parzialmente) convertito in capitale (dato che l’altra parte del credito era stata oggetto di rinunzia), chiedeva l’insinuazione al passivo per l’intero credito dallo stesso vantato al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, comprensivo dunque della parte falcidiata e/o convertita in azioni. Il Tribunale di Reggio Emilia negava l’ammissione allo stato passivo per le seguenti ragioni: (i) il concordato preventivo era stato interamente eseguito in relazione alla conversione del credito in azioni; (ii) le operazioni straordinarie, e in particolare l’operazione di aumento del capitale sociale a seguito della [continua ..]
La questione posta all’attenzione del tribunale di Reggio Emilia non è regolata dalla legge fallimentare, che si limita, per un verso, a consentire l’ammissibilità di proposte di concordato che prevedano l’attribuzione di azioni ai creditori e, per altro verso, a disciplinare le conseguenze della risoluzione del concordato preventivo in via generale, senza dettare regole specifiche per ipotesi di concordato preventivo in cui la soddisfazione dei creditori è avvenuta mediante titoli rappresentativi di capitale di rischio. Come detto, la questione non ha precedenti in giurisprudenza. In dottrina, i pochi autori che hanno affrontato la questione de quo hanno espresso due distinte posizioni, accomunate dall’assunto che la risoluzione del concordato non potrebbe mai determinare la “revoca” dell’operazione straordinaria (rectius dell’aumento del capitale sociale) [4]. In estrema sintesi: (i) un Autore [5] ha ritenuto che la risoluzione del concordato abbia effetti retroattivi, con i limiti di cui all’art. 140 legge fall., e in particolare dei commi 3 e 4 della predetta disposizione (dettata in materia di concordato fallimentare, ma applicata anche al concordato preventivo). Pertanto, sotto il profilo strutturale, i creditori non potrebbero essere obbligati a restituire le partecipazioni assegnate in esecuzione del concordato preventivo, così come le somme loro corrisposte; sotto il profilo funzionale (esaminando quindi gli interessi tutelati dalla norma), la retroattività della risoluzione (così come la irripetibilità delle somme riscosse) è dettata nell’esclusivo interesse dei creditori. Da ciò conseguirebbe che i creditori, pur non essendo tenuti a restituire le prestazioni riscosse, sono legittimati a farlo [6]. La risoluzione non travolgerebbe però la deliberazione volta a creare le partecipazioni [7], che quindi rimarrebbe ferma, ma la sola assegnazione delle azioni ai creditori, essendo quest’ultimo l’atto esecutivo del concordato. Ciò con un duplice effetto: per un verso, i creditori potrebbero decidere di restituire le partecipazioni ricevute alla società emittente, ottenendo così il diritto di far valere nel successivo fallimento il credito originario; per altro verso, la partecipazione restituita dovrebbe essere riconsegnata agli originari [continua ..]
Per sottoporre a verifica critica la soluzione adottata dal tribunale di Reggio Emilia occorre a mio avviso approfondire la relazione fra la proposta di concordato preventivo e la delibera di aumento del capitale sociale, e quindi analizzare la natura dell’operazione di conversione del credito in azioni effettuata in questo contesto, anche per il suo impatto civilistico sul credito convertito in capitale. Fatto ciò, sarà possibile verificare su quali passaggi intervenga la risoluzione del concordato e quali altri elementi rimangano invece indifferenti alla risoluzione dello stesso.
A ben vedere, quando una proposta di concordato prevede la conversione di crediti in azioni, detta proposta prevede due diverse operazioni negoziali, distinte ancorché fra loro collegate: (a) la delibera di aumento del capitale sociale da parte dell’assemblea della società in crisi, a servizio della predetta conversione; e (b) la sottoscrizione del predetto aumento di capitale da parte dei creditori per effetto dell’omologazione del concordato preventivo. Per la prima operazione, secondo la dottrina maggioritaria, non sarebbe sufficiente la semplice approvazione (e omologazione) del concordato preventivo (contenente la proposta di attribuire ai creditori azioni della società debitrice), ma sarebbe necessaria una espressa deliberazione di aumento di capitale adottata dall’assemblea della società (debitrice) [11]. A sua volta, l’operazione di aumento di capitale è ordinariamente suddivisibile in quattro fasi [12]: (i) la deliberazione di aumento di capitale da parte dell’organo assembleare [13]; (ii) la sottoscrizione delle azioni da parte dei soci o dei terzi [14]; (iii) il versamento dell’importo necessario per la sottoscrizione del capitale nella misura prevista dalla deliberazione e dell’eventuale soprapprezzo [15]; (iv) il decorso del termine di efficacia dell’aumento previsto dalla deliberazione e l’applicazione delle regole su scindibilità o inscindibilità dell’aumento medesimo. Occorre dunque chiedersi dove si inserisca il concordato preventivo (omologato) in questa “filiera”: a mio avviso esso, rappresentando uno strumento mediante il quale le azioni vengono attribuite ai creditori in ragione della ristrutturazione del credito che essi vantano nei confronti della società debitrice, influisce sulla disciplina dell’aumento del capitale sociale in relazione ai punti (ii) e (iii) che precedono [16]. In particolare, esso rappresenta uno strumento di sottoscrizione e di liberazione delle azioni, rectius un accordo mediante il quale la società e il terzo si accordano (con un meccanismo sui generis regolato dagli artt. 160 ss. legge fall.) sulla sottoscrizione e sulla liberazione delle azioni da parte del terzo [17]. In sostanza, la proposta omologata è una tecnica di sottoscrizione e liberazione delle azioni emesse dalla [continua ..]
Prima di procedere oltre e di verificare quali sono le conseguenze della risoluzione del concordato sul processo di attribuzione delle azioni occorre chiedersi ulteriormente in cosa consista l’attribuzione delle azioni ai creditori [22]. Si è detto che la conversione del credito in azioni configura una datio in solutum, oppure una novazione [23]. Nessuna delle due soluzioni appare pienamente convincente. (1) Quanto alla ricostruzione della fattispecie in termini di datio in solutum, ipotizzando che la società, con accordo nei confronti del creditore, si impegni ad attribuire azioni di nuova emissione al creditore medesimo al posto di adempiere l’originaria obbligazione di pagamento [24], essa sembra avere vari punti deboli: (a) la conversione dei crediti in azioni, sotto il profilo logico, presuppone sempre il versamento alla società di quanto necessario per la liberazione delle azioni di nuova emissione. A sua volta, l’estinzione dell’obbligazione gravante in capo all’oblato presuppone la manifestazione della volontà dello stesso di sottoscrivere le azioni. Nel caso di specie (conversione del credito in azioni), la liberazione del corrispettivo necessario per aumentare il capitale sociale avviene per effetto della rinuncia al credito da parte del creditore; e quest’ultima a sua volta presuppone l’approvazione del concordato. L’attribuzione di partecipazioni sociali da parte della società emittente le azioni a un creditore non è quindi una forma di adempimento dell’obbligo di pagamento che gravava sulla società debitrice prima dell’apertura della procedura, ma presuppone sempre un’ulteriore manifestazione del consenso, che nella specie è rappresentata dall’approvazione del concordato preventivo (che, come poc’anzi rilevato, è una tecnica di sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale); (b) la datio della partecipazione sociale da parte della società in sostituzione del credito non convince, inoltre, perché lascerebbe “ingiustificatamente senza titolo il procedimento deliberativo e la conclusione del contratto di sottoscrizione” [25]. (2) In dottrina si è talvolta sostenuto che la conversione del credito in azioni debba essere considerata una forma di novazione (per la verità solo con riguardo a fattispecie dove [continua ..]
Così inquadrate la struttura del procedimento di conversione del credito in azioni e la natura dell’operazione di conversione, è ora possibile affrontare la questione delle conseguenze della risoluzione dell’operazione presupposto sulla attribuzione di azioni ai creditori. A ben vedere, nel caso in esame, la richiesta del creditore in bonis cui sono state attribuite le azioni di veder ammesso il proprio credito nel fallimento del debitore postula che la risoluzione del concordato preventivo faccia riemergere con efficacia retroattiva il diritto di credito vantato nei confronti della società in procedura, ponendo nel nulla il titolo (il concordato preventivo e più in particolare l’accordo di compensazione volontaria che esso rappresenta) in base al quale gli erano state attribuite le azioni della società riorganizzata o meglio aveva estinto il debito da sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale. Occorre innanzi tutto distinguere gli effetti che la risoluzione del concordato ha sul piano organizzativo della società da quelli che la stessa produce, per così dire, sul piano “individuale”, ovvero sull’attribuzione patrimoniale che il singolo creditore riceve dal debitore in esecuzione del concordato preventivo. Si noti che quest’ultimo profilo è l’unico che nella fattispecie in concreto viene in rilievo. Quanto al primo profilo, come ritenuto dalla dottrina all’unanimità [42], la delibera di risoluzione non può avere alcun effetto sul piano organizzativo. Infatti, se anche la risoluzione del concordato preventivo, facendo venir meno l’accordo che sta alla base dell’attribuzione delle azioni ai creditori, determinasse un vizio delle fasi di sottoscrizione e di liberazione dell’aumento del capitale sociale, ciò non comporta la “revoca” dell’operazione straordinaria, per due ragioni. In primo luogo, come correttamente rilevato dalla sentenza qui in commento, i vizi delle delibere di aumento del capitale sociale possono essere fatte valere solo entro ben definiti limiti temporali, dettati dagli artt. 2379-ter e 2444 c.c., decorsi i quali i rimedi “demolitori” non possono essere più fatti valere [43]. In secondo luogo, la «modifica irreversibile» dell’organizzazione societaria discende dal “principio generale di [continua ..]