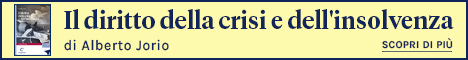
Articoli Correlati: srl - disciplina - capitale sociale - conferimenti - riduzione del capitale sociale per perdite - persone fisiche
La s.r.l. semplificata (e la s.r.l. con capitale ridotto) nel sistema societario - 1. Premessa - 2. I profili comuni di disciplina: capitale sociale, conferimenti, riserva legale. - 3. (Segue) L’applicabilità (e l’applicazione) delle regole sulla riduzione del capitale sociale. - 4. (Segue) Finanziamenti dei soci e responsabilità del socio cogestore. - 5. La disciplina specifica della s.r.l.s.: il requisito soggettivo dei soci e la presenza nella compagine sociale di soggetti che ne sono sprovvisti. - 6. (Segue) Il trasferimento della quota a soggetti diversi dalle persone fisiche. - 7. Sulla modificabilità dello statuto standard di s.r.l.s. - 8. La s.r.l.s. come modello e il passaggio da questa alla s.r.l. e viceversa. - 9. Sulla possibilità di applicare l’art. 2463, 4° comma, durante societate. - NOTE
Questo contributo affronta in chiave sistematica le principali questioni emerse in merito alle fattispecie in esame. Il quadro normativo in materia non pare ancora stabile, ed è facile, pertanto, che le osservazioni qui proposte siano destinate ad essere in parte riviste in futuro; non tanto perché è probabile la revisione del modello standard di s.r.l.s., quanto, piuttosto, perché, sul piano del diritto comunitario, se la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio, formulata dalla Commissione Europea il 9 aprile 2014, verrà recepita, si configurerà la possibilità di costituire una Societas Unius Personae in assenza di controllo notarile [1], che potrebbe in concreto riaprire tutte le questioni derivanti dalla primissima versione della norma relativa alla s.r.l.s. (poi non confermata nel testo effettivamente entrato in vigore), che ne ammetteva appunto la costituzione per mezzo di scrittura privata. Allo stato attuale, si può osservare che la disciplina della s.r.l. semplificata risulta di grande interesse (e rilievo pratico) non solo per quanto dispone nello specifico, ma anche, e soprattutto, per le sue interrelazioni con la restante disciplina della s.r.l., alla luce delle quali sarà possibile comprenderne le effettive modalità di funzionamento. I profili d’indagine più significativi risultano, del resto, comuni alla s.r.l.s. e alla s.r.l. (di “diritto comune”) che utilizzi la possibilità offerta dall’art. 2463, 4° comma, che ammette un capitale ridotto [2] anche utilizzando il modello ordinario. Si pensi all’applicazione della disciplina in materia di riduzione del capitale [3] e all’impatto che in un contesto di capitalizzazione (tendenzialmente) simbolica esplicheranno altre due cruciali regole previste in materia di s.r.l. Il riferimento è alla postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci in situazioni di squilibrio finanziario e alla possibile responsabilità del socio cogestore che abbia intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi [4]. Si tratta di istituti segnalati, già all’indomani della riforma societaria, come problematici e comportanti il rischio di abbandono della s.r.l. [5], e che dovranno, pertanto, essere considerati nella loro [continua ..]
Sia per la s.r.l. che utilizzi la possibilità prevista dall’art. 2463, 4° comma, che per la s.r.l.s., il capitale sociale, pari almeno ad un euro, incontra come limite massimo l’importo di diecimila euro, ed è caratterizzato da particolarità inerenti all’oggetto del conferimento e alle modalità di versamento. Sotto il primo profilo, i conferimenti devono farsi in denaro, e non vi è alcun richiamo alla possibilità di utilizzare la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prevista dall’art. 2464, 4° comma [10], così come ai conferimenti in natura, che dovranno considerarsi esclusi. Tale preclusione è stata motivata in base al fatto che il denaro rappresenta un conferimento preferibile rispetto alle altre entità economiche potenzialmente conferibili [11]; ma è forse più verosimile individuare una diversa ragione, che potrebbe giustificare non solo l’impossibilità di conferire beni, ma anche di utilizzare le modalità alternative di versamento dei conferimenti in denaro (nell’ipotesi in cui divengano concretamente disponibili a seguito dell’emanazione della normativa di attuazione), consistente nella verosimile assenza dell’intento dei soci di affrontare le spese connesse alla relazione di stima e all’ottenimento della garanzia [12], costituendo una società che potrebbe avere capitale simbolico e che comunque dovrà avere capitale inferiore a diecimila euro. Sotto il secondo profilo, il versamento del conferimento in denaro all’organo amministrativo è divenuto, a seguito della modifica dell’art. 2464, 4° comma, modalità di generale applicazione, destinata a sostituire l’originario versamento presso una banca [13]. Manca, in relazione alla s.r.l.s., la specificazione invece contenuta nella disciplina di generale applicazione, ove si prevede che i mezzi di pagamento sono indicati nell’atto costitutivo, limitandosi l’art. 2463-bis, 2° comma, n. 3, a stabilire che il conferimento deve farsi in denaro. L’utilizzazione del contante, come noto, incontra i limiti derivanti dalle cosiddette norme antiriciclaggio [14]; il versamento del denaro potrà essere la modalità prescelta se la società abbia un capitale simbolico o se l’importo dei singoli conferimenti sia inferiore al limite massimo [continua ..]
Vanno ora affrontate unitariamente le questioni inerenti all’applicazione delle regole sulla riduzione del capitale sociale per perdite, premettendo l’analisi dell’applicabilità della relativa disciplina alla s.r.l.s. La natura potenzialmente simbolica della somma imputata a capitale potrebbe, infatti, far dubitare dell’applicabilità della disciplina vincolistica alla s.r.l.s. [33] (e, del resto, in termini sostanzialmente analoghi, pur se formalmente diversi, non sussistendo un rinvio alla disciplina nei limiti della compatibilità, si potrebbe anche porre il problema del coordinamento tra capitale simbolico e disciplina della sua riduzione nel caso della s.r.l. che si sia avvalsa della possibilità prevista dall’art. 2463, 4° comma). Già sotto questo profilo, bisogna però sottolineare che, come detto, il capitale è potenzialmente, non necessariamente simbolico: e che, stando al caso limite, variare da un caso all’altro la disciplina del capitale potrebbe voler dire considerare rilevante una differenza pari ad un centesimo (da 9.999,99, soglia massima per la s.r.l.s. o la s.r.l. con capitale ridotto, a 10.000 euro) [34]. Lo stesso riferimento letterale al capitale sociale porta a concludere nel senso dell’applicabilità della relativa disciplina, anche alla luce della dilazione temporale in caso di riduzione del capitale per perdite prevista invece per le start up, che conferma, nelle altre fattispecie, l’applicazione della disciplina generale [35], compatibile con una società comunque caratterizzata da un capitale fisso [36]. Ulteriore argomento portato a suffragio di questa tesi era, poi, l’assenza di una disciplina alternativa di tutela dei creditori, in specie in merito a vincoli di utilizzazione degli utili [37]. Tuttavia, l’introduzione della già menzionata disciplina contenuta nell’art. 2463, 5° comma, non sembra cambiare le conclusioni raggiunte, al contrario rafforzandole, dato che le uniche utilizzazioni ammesse per tale riserva sono l’imputazione a capitale e la “copertura di eventuali perdite”. A ben vedere il legislatore dimostra di dare per scontata l’applicazione della disciplina generale in materia di riduzione del capitale, che, come normalmente avviene, opererà una volta che, azzerate le eventuali riserve, tali perdite incidano [continua ..]
Due ulteriori istituti che nel caso delle s.r.l. con capitale ridotto costituiranno aspetti di particolare delicatezza sono quelli previsti dall’art. 2467 e dall’art. 2476, 7° comma. La norma sui finanziamenti soci è destinata verosimilmente ad applicarsi ad ogni operazione di finanziamento da parte dei soci, in qualsiasi momento effettuata [49], almeno quando il capitale sia prossimo alla soglia minima di un euro. Quanto versato dai soci per consentire lo svolgimento dell’attività sociale sarà considerato come conferimento ogni volta che si dovrebbe ritenere improbabile l’ottenimento di un finanziamento da un terzo, che, nel caso di specie, può considerarsi, almeno tendenzialmente, la norma. Di questo rischio i soci che scelgano di costituire una s.r.l. con capitale ridotto devono essere consci; non si tratta di un’indebita eliminazione del beneficio della responsabilità limitata, talora implicitamente derivante da certe impostazioni in materia di applicazione della disciplina della riduzione del capitale per perdite, ma della concreta attuazione di un istituto volto in termini generali a scongiurare fenomeni distorsivi del corretto rapporto tra mezzi propri e dimensioni dell’attività d’impresa, che pregiudicherebbero i creditori. In merito, invece, alla possibile responsabilità del socio che abbia intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi per la società (o i terzi), va sottolineato il possibile rischio di un maggior rigore, da parte della giurisprudenza, nel vaglio di tale responsabilità nel caso di una s.r.l.s., correlato alla potenziale emersione di fenomeni di sostanziale abuso del modello [50]. A tale caso verosimilmente corrisponderà, anche sotto questo profilo, quello della s.r.l. costituita con capitale ridotto. È opportuno, a tal proposito, proporre un’interpretazione equilibrata, che, tenendo conto dei diversi interessi in gioco, non avalli fenomeni di abuso, ma nemmeno letture troppo severe in merito alla posizione dei soci, comportanti un’inaccettabile inversione delle regole di base, mettendo, di fatto, in discussione la limitazione della loro responsabilità nel regime di una società di capitali. Se, applicando l’art. 2476, 7° comma, ai casi ora in esame, si dovesse, ad esempio, dare una lettura troppo estensiva del carattere intenzionale del comportamento del [continua ..]
Vanno ora esaminati gli aspetti di disciplina peculiari della s.r.l.s. Dopo l’eliminazione della s.r.l.c.r., con il conseguente venir meno dei requisiti di età originariamente previsti per la s.r.l.s., l’unico requisito soggettivo rimasto consiste nella necessità che soci di questa siano persone fisiche. Ciò implica, ad esempio, l’impossibilità di utilizzare il modello come articolazione di gruppi societari, e in generale in ogni altra ipotesi in cui la compagine non possa essere così formata. Nel vigore di una disciplina in parte diversa da quella attuale, e in particolare quando il trasferimento a soggetti sprovvisti del requisito anagrafico un tempo richiesto era espressamente vietato, si era evidenziato che l’accesso alla s.r.l.s. era riservato alle persone fisiche in quanto l’obiettivo perseguito dal legislatore era quello di favorire la nascita di nuove attività economiche, non di consentire particolari articolazioni del rischio di impresa [53]. Queste considerazioni paiono comunque mantenere attualità anche nel contesto normativo rinnovato, visto che, eliminando il requisito anagrafico di appartenenza alla s.r.l.s., il legislatore non ha soppresso il riferimento alle persone fisiche come uniche abilitate alla costituzione di tale modello societario. Si tratta allora, innanzitutto, di capire quali conseguenze derivino dall’eventuale presenza in compagine di soci diversi dalle persone fisiche, nella remota ipotesi di una duplice svista, del notaio rogante prima e degli addetti al registro delle imprese poi, e, in seguito [54], quali problematiche si pongano in relazione al trasferimento delle quote a soggetti sprovvisti del requisito in esame. Prima dell’ultima novella, si era ritenuto che la presenza nella compagine sociale di soci diversi dalle persone fisiche (non necessariamente persone giuridiche, ma anche entità sprovviste di personalità) comportasse l’obbligo degli amministratori di accertare la causa di scioglimento di quella che sarebbe stata, a dispetto della denominazione di s.r.l.s., una s.r.l. (ordinaria) con capitale inferiore al minimo [55]. A tale proposito, meritano un breve approfondimento l’impatto dell’ultima riforma dell’art. 2463 su questa soluzione e, in termini più generali, la possibilità stessa di procedere alla riqualificazione della società. Sotto il primo [continua ..]
Per quanto attiene al trasferimento della quota ad un soggetto diverso da una persona fisica, nel vigore dell’originaria disciplina esso era ritenuto nullo in base all’applicazione analogica della norma che prevedeva tale sanzione per il trasferimento ad un soggetto avente età anagrafica superiore a quella consentita [75]. Dopo l’abrogazione di questa, conseguente all’eliminazione del limite massimo di età per i soci della s.r.l.s., si tratta di capire se il trasferimento ad un soggetto diverso da una persona fisica sia ancora vietato, e, se la risposta a tale quesito sia positiva, quali siano le conseguenze della violazione del divieto. Si è ritenuto, proprio in virtù della accennata abrogazione, che tale trasferimento debba considerarsi attualmente consentito, dal momento che la presenza di sole persone fisiche all’interno della compagine sociale della s.r.l.s. apparterrebbe alla disciplina specifica della costituzione di tale società [76]. Ma se è vero che il trasferimento di quote a soggetti diversi dalle persone fisiche, che per definizione non avrebbero potuto rispettare il requisito anagrafico richiesto [77], poteva ritenersi implicitamente vietato dalla norma abrogata, non pare altrettanto certo che alla scomparsa del citato divieto debba necessariamente accompagnarsi l’ammissibilità di tale trasferimento. L’intervenuta modifica normativa si giustifica, come detto, alla luce del venir meno del requisito anagrafico che prima era richiesto per le persone fisiche appartenenti alla s.r.l.s.; ma non sembra risolutiva in punto di successiva apertura della compagine sociale ad enti [78]. Se questa dovesse ritenersi consentita, sia pur solo dopo che la società sia venuta ad esistenza, sfuggirebbe il senso della limitazione, chiaramente presente in merito alla fase costitutiva. Altra opinione reputa, infatti, precluso il trasferimento di quote a soggetti diversi dalle persone fisiche, proprio argomentando dal divieto relativo alla costituzione, che non è stato rivisto dal legislatore [79]; trasferimento che, coerentemente, diverrebbe invece consentito in caso di conversione della s.r.l.s. in s.r.l. (ordinaria) [80]. A favore di tale impostazione restrittiva militano due argomenti: la ratio del divieto, riconducibile al favor del legislatore per l’imprenditoria che ha come protagonisti (solo) persone [continua ..]
Con l’ultima riforma il legislatore ha preso posizione in merito alla possibilità di modificare lo statuto standard, anche se con una previsione che probabilmente darà luogo ad ulteriori discussioni. Prima che la s.r.l.c.r. venisse espunta dall’ordinamento, era diffusa in dottrina la tesi secondo la quale lo statuto predisposto dal legislatore per la s.r.l.s. non era modificabile dalle parti [85], che, in sostanza, avrebbero comunque potuto ricorrere all’altro modello di società a capitale (potenzialmente) simbolico se avessero desiderato prevedere una particolare disciplina statutaria. Non mancava, tuttavia, un’opposta opinione, peraltro fondata su solidi argomenti [86], e sostanzialmente accolta anche dal Ministero dello Sviluppo Economico [87], che riteneva possibile la modifica del modello predisposto pur scegliendo di costituire una s.r.l.s. In sede di conversione del decreto legge con cui la s.r.l.c.r. è stata eliminata, e le s.r.l.c.r. già costituite riqualificate in s.r.l.s., il legislatore ha specificato, intervenendo sul testo dell’art. 2463-bis, che «Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili». A una prima lettura, sembra pertanto che, se si costituisce una s.r.l.s., l’utilizzazione del modello standard di statuto sia necessaria, non essendone consentite modifiche o integrazioni [88]. In tal senso si è espresso il Ministero dello Sviluppo Economico, mediante un parere emesso in seguito a una richiesta di chiarimenti proveniente da uno studio professionale [89]. Considerando, però, che l’inderogabilità è riferita alle clausole di tale modello, può essere proposta qualche ulteriore osservazione. Innanzitutto, può sembrare discutibile il concetto stesso di clausola inderogabile: l’inderogabilità pare, infatti, predicato che meglio si attaglia ad una norma, piuttosto che ad una clausola statutaria, per quanto contenuta in un decreto ministeriale, come nel caso di specie. Inoltre, riferendosi alle clausole, non al modello, questa inderogabilità non dovrebbe implicare l’impossibilità di aggiungerne altre, che integrino la disciplina senza entrare in conflitto con quanto previsto dal modello stesso [90]. Anche se è probabile che intenzione del legislatore fosse precludere qualsiasi modifica al modello standard [91], la [continua ..]
È comunemente ritenuto che il legislatore, introducendo la s.r.l.s., non abbia inteso creare un nuovo tipo sociale [105], che non poteva configurarsi solo in relazione alla differenza inerente all’importo del capitale sociale [106], del resto divenuta a seguito dell’ultima novella meramente eventuale, data la possibilità anche per la s.r.l. di avere capitale pari a 1 euro. Peraltro, in termini generali, è molto dibattuta la stessa configurabilità di elementi tipizzanti la s.r.l. [107], tuttavia individuati dall’orientamento preferibile nel carattere chiuso della società [108] e nella limitazione della responsabilità dei soci [109]. Elementi che, a ben vedere, puntualmente ricorrono anche nella s.r.l.s. Se la s.r.l.s. non costituisce, quindi, tipo autonomo, non si parlerà di trasformazione [110], ma di conversione [111], quando ad essa approdi una s.r.l.; e se questa conversione che potrebbe essere definita “progressiva”, portando da una s.r.l.s. ad una s.r.l. (ordinaria), non pone particolari problemi, altrettanto non si può dire per il passaggio inverso. Il passaggio dalla s.r.l.s. alla s.r.l. è, infatti, oltre che consentito senza particolari vincoli temporali (potrebbe di per sé avvenire anche il giorno dopo la costituzione [112]), favorito dal legislatore, che ammette l’imputazione a capitale della riserva formata a norma dell’art. 2463, 5° comma [113]. Tale passaggio, non integrando una trasformazione, non determina l’acquisizione del diritto di recesso in capo al socio dissenziente, dal momento che non rientra in una delle fattispecie contemplate dall’art. 2473 [114], e che sarebbe, peraltro, contraddittorio con la finalità di favorire la crescita di nuove imprese esporre la società che sta evolvendo alle conseguenze economiche del recesso del socio dissenziente. Più controversa, come accennato, è l’ammissibilità di un passaggio inverso, e quindi della conversione di una s.r.l. già esistente in una s.r.l.s. L’orientamento che esclude tale possibilità, talora argomentando dalla scarsa utilità di questo passaggio [115], si fonda sulla funzione della norma, consistente nel favorire la nascita di nuove imprese, non nel mantenere in vita imprese già esistenti e che potrebbero essersi anche [continua ..]
La possibilità in esame è negata da chi reputa applicabile la regola prevista dall’art. 2463, 4° comma, solo al momento costitutivo [130]. Tuttavia, la disciplina contenuta nell’art. 2463, 4° comma, pur essendo dettata a proposito della costituzione della società, non contiene alcun riferimento espresso ad una limitazione a tale momento della sua operatività. Se dunque le si può riconoscere portata generale, va ammessa la riduzione reale (nonostante qualche contrario avviso [131]) o nominale del capitale al di sotto dei diecimila euro, consentendo, così, alla s.r.l. che subisca perdite tali da intaccare tale soglia di continuare ad operare [132]. Non è significativo, in senso contrario, il rinvio che gli artt. 2482 e 2482-ter continuano ad operare all’art. 2463, n. 4, ascrivibile piuttosto ad un difetto di coordinamento [133]. Analoga possibilità spetterà anche ad una s.p.a. che si trasformi in s.r.l. [134]. La riduzione nominale del capitale a un valore simbolico (o la trasformazione di una s.p.a. in s.r.l. con capitale ridotto a seguito di riduzione nominale) comportano, per i creditori, gli stessi rischi sopra esaminati in merito alla conversione regressiva. Analogamente a quanto già visto a tal proposito, si può ritenere che solo apparentemente l’operazione in esame sia davvero diversa da altre riduzioni nominali di capitale comunemente ammesse in sostanziale assenza di strumenti (societari) di tutela per i creditori. È l’ipotesi, già formulata, della riduzione nominale da un capitale molto elevato ad uno che rispetti i tradizionali minimi, messa a confronto con la riduzione nominale dall’importo di diecimila euro all’importo (simbolico) di un euro. Anche in tal caso, pertanto, non si ritiene di poter escludere l’operazione, né di doverla accompagnare a specifiche cautele di natura societaria a favore dei creditori. A questo proposito giova però osservare, sia pur in estrema sintesi, che nell’ipotesi ora in esame (e in quella analoga di conversione in s.r.l.s. [135]) un mezzo di tutela dei creditori diverso dalla garanzia costituita dal capitale sociale può essere già rinvenuto nel nostro ordinamento, ed è costituito dalla possibile responsabilità degli amministratori che si rendano inadempienti rispetto ai loro obblighi di [continua ..]