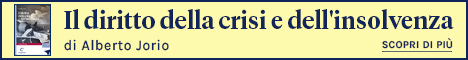
The essay aims to reconstruct the discipline operating in Italian private companies in relation to the competence on the appointment and revocation of directors, thus clarifying the apparent contradictions of the relative regulations. This investigation, however, is grafted into the broader issue concerning the suppression of the management organ in private companies. The negative solution of this problem, which we have decided to adhere to, in fact, allows to identify as a typical rule that of the competence in charge of the plurality of the partners; a rule, moreover, that, according to the provision of law, can be derogated from the statutory autonomy. Hence the need to clarify the scope of the exemption right, to affirm that this is expressed in placing limits on the competence pertaining to the plurality of members, but does not extend to the point of nullifying it.
Articoli Correlati: nomina e revoca degli amministratori
1. Il raffronto tra l’art. 2475, 1° comma e l’art. 2479, 2° comma, n. 2, c.c. - 2. Qualificazione tipologica della s.r.l. ed essenzialità dell’organo gestorio - 3. La mancata indicazione degli amministratori nell’atto costitutivo - 4. Il 'ruolo preminente' dell’art. 2475, 1° comma - 5. La competenza sulla revoca degli amministratori in capo alla pluralità dei soci: profili ricostruttivi - 5.1. Eccezioni - NOTE
La norma di riferimento relativa all’attribuzione del potere gestorio nella società a responsabilità limitata è l’art. 2475, 1° comma, c.c. che fissa la regola secondo cui alla decisione dei soci è demandato il potere di nominare gli amministratori, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo; regola però che sembra essere contraddetta dal dato letterale dell’art. 2479, 2° comma, n. 2, c.c. secondo cui la nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci solo se prevista nell’atto costitutivo. Dal che la necessità di chiarire la portata delle due norme al fine di risolvere tale contraddittorietà [[1]]. Soluzioni diverse sono state prospettate in dottrina. Si è, dapprima, riconosciuto ruolo preminente all’art. 2475, nel senso che la previsione ivi contenuta che riserva la competenza in ordine alla nomina degli amministratori alla decisione dei soci, ma ne consente la derogabilità con espressa previsione statutaria, sarebbe ulteriormente confermata dal disposto dell’art. 2479 [[2]]. Soluzione che non appare sufficientemente motivata, in quanto propone una lettura che supera tout court il dato testuale dell’art. 2479, nella sua differente formulazione rispetto all’art. 2475, senza una più precisa giustificazione [[3]]. Un’ulteriore ipotesi ricostruttiva proposta si fonda sul riconoscere alle due norme una differente funzione [[4]]: l’art. 2475 riguarderebbe la legittimazione passiva (chi possa essere nominato amministratore), cosi che verrebbe unicamente a stabilire come regime legale la nomina di soci alla carica gestoria e la sua derogabilità (nomina anche di terzi) con espressa previsione dell’atto costitutivo, per contro l’art. 2479 atterrebbe alla legittimazione attiva (a chi spetti il potere di nomina). Con la precisazione, però che la norma, limitandosi a prevedere che la riserva alla competenza decisionale dei soci in ordine all’attribuzione dell’incarico gestorio opererebbe solo in conseguenza di un’espressa previsione statutaria, non detterebbe una diversa regola legale suppletiva, cioè la regola di default; pertanto non individuerebbe il modello legale [[5]], modello che dovrebbe trarsi da altre norme della disciplina societaria che possano assolvere a tale scopo. A questo proposito [continua ..]
La soluzione al quesito innanzi esposto si trae logicamente dalla individuazione del regime legale (residuale) che caratterizza tipicamente la società a responsabilità limitata, il che significa precisare la collocazione tipologica della s.r.l, in seguito alla riforma, e quindi se si debba ricondurla alla classe di società di capitali, o invece a quella di società di persone. Va accolta, a riguardo, la posizione ampiamente sostenuta in dottrina, secondo cui la società a responsabilità limitata va qualificata come società di capitali per la presenza degli indici caratterizzanti quest’ultima come [[9]]: le partecipazioni sociali (ex. artt. 2464 e 2468 c.c. [[10]]) determinate come frazioni del capitale sociale prefissato nel suo ammontare e proporzionali al conferimento, la libera trasferibilità delle (partecipazioni) stesse (ex art. 2469 c.c. [[11]]) e di conseguenza la naturale variabilità della compagine personale, la sussistenza della disciplina in tema di capitale sociale relativa alla sua formazione e conservazione e modifica [[12]] (ex artt. 2481-bis-2482-ter), l’ammissibilità della costituzione unilaterale della società. La qualificazione in termini capitalistici della società a responsabilità limitata ha come portato che serve ad individuare il modello legale di organizzazione interna, quale appunto un’organizzazione di tipo corporativo, intesa questa come complesso di regole che fissano, per il realizzarsi del programma speculativo, la distribuzione di competenze decisionali e dichiarative tra uffici, a cui sono preposti soggetti nominati dalla compagine sociale [[13]]; organizzazione corporativa della s.r.l., però, attenuata perché sono ammissibili deroghe, ma queste non possono giungere a vanificare la distinzione tra competenze attribuite alla pluralità dei soci e competenze gestorie, perché, se fosse altrimenti, si avrebbe una s.r.l. completamente priva dell’apparato organizzativo di tipo corporativo e non semplicemente “attenuato”. Pertanto deve ritenersi essenziale, per il corretto funzionamento dell’attività sociale, la creazione dell’(ufficio) organo gestorio,e quindi inammissibile la mancanza dello stesso [[14]]. Con la necessaria precisazione [[15]]che non si ha mancanza [continua ..]
Dalle considerazioni prima esposte consegue come non possa ammettersi il silenzio dell’atto costitutivo sulla nomina degli amministratori [[37]]; di qui la necessità di chiarire, prima di (e anche al fine di) precisare il significato da attribuire all’art. 2479, 2° comma, n. 2, cosa comporti tale eventuale mancata indicazione [[38]]. Non v’è dubbio che in caso di omessa nomina degli amministratori nell’atto costitutivo grava in capo al notaio rogante l’obbligo di chiedere ai soci stipulanti di colmare tale lacuna, pena l’impossibilità di procedere all’iscrizione dell’atto stesso, perché incompleto, nel registro delle imprese [[39]]. Più problematica la ricerca della soluzione interpretativa nell’ipotesi di avvenuta iscrizione; tale mancata indicazione, se certamente non può determinare la nullità della società ex art. 2332 c.c., norma applicabile alla s.r.l. in quanto espressamente richiamata nel 3° comma dell’art. 2463, proprio perché non è riconducibile a nessuna delle cause di nullità ivi tassativamente previste [[40]], comporta altre rilevanti conseguenze. In assenza di nomina degli amministratori nell’atto costitutivo, la società viene ad esistenza priva dell’organo gestorio, non valendo a riguardo rispetto alla s.r.l., come si è più innanzi chiarito, una regola suppletiva [[41]]; e ciò determina l’impossibilità in senso oggettivo, per la società stessa, di svolgere l’attività che costituisce l’oggetto sociale secondo le regole tipiche della s.r.l [[42]]. Individuati così gli effetti derivanti dalla omessa indicazione degli amministratori nell’atto costitutivo deve riconoscersi che la stessa va ricondotta [[43]] alla fattispecie di impossibilità di conseguire l’oggetto sociale prevista nell’art. 2484, n. 2, c.c. come causa di scioglimento della società [[44]]. L’effetto dissolutorio a cui si giunge con la soluzione proposta, peraltro, non opera in maniera “ineluttabile” [[45]], in quanto in base all’inciso previsto sempre al n. 2 dell’art. 2484 non viene a prodursi qualora sia convocata [[46]] senza indugio «l’assemblea per deliberare sulle opportune [continua ..]
Aver cosi chiarito l’ineliminabilità dell’organo amministrativo nella s.r.l. e la necessarietà dell’esplicita indicazione nell’atto costitutivo di coloro a cui è affidata l’amministrazione, serve a confermare che è l’art. 2475, 1° comma, c.c. a fissare la regola di default, propria della s.r.l., secondo cui è riconosciuta in capo alla pluralità dei soci la competenza “primaria” sull’attribuzione dell’incarico gestorio e quindi sulla nomina degli amministratori. Si deve di conseguenza precisare il significato della previsione dell’art. 2479, 2° comma, n. 2; a questo proposito è necessario volgere l’attenzione ad ulteriori aspetti caratterizzanti la disciplina della s.r.l. in tema di potere gestorio. Il riferimento è alla norma dell’art. 2468, 3° comma, c.c. [[53]] che consente di prevedere nell’atto costitutivo «l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società» [[54]]; in particolare si è evidenziato che la formulazione della norma “singoli soci” chiarisce che l’attribuzione deve riguardare il socio in quanto persona, inoltre che il contenuto della stessa va inteso ricomprendere il diritto tanto di nominare uno o più amministratori, quanto di essere nominato amministratore [[55]]. In base a questa norma pertanto è prevista in capo alla pluralità di soci la facoltà di derogare statutariamente alla regola legale della spettanza in capo alla stessa del potere di nominare gli amministratori; deroga però che si atteggia diversamente a seconda del diritto attribuito al singolo socio. Infatti nella prima ipotesi (diritto del socio di nominare uno o più amministratori) la pluralità dei soci limita la proprio competenza originaria di nomina degli amministratori riconoscendo direttamente in capo al singolo socio il potere concorrente ma circoscritto alla designazione di alcuni componenti dell’organo gestorio. Nella seconda ipotesi (diritto ad essere amministratore) tale competenza originaria è sempre totalmente in capo alla pluralità dei soci, però viene ad essere limitata la competenza “successiva” sul rinnovo dell’affidamento della carica gestoria: questa, infatti sussiste unicamente [continua ..]
Ulteriore indagine da svolgere, certamente connessa con la problematica fin qui esaminata relativa alla competenza sulla nomina degli amministratori, è l’individuazione delle regole in tema di revoca dalla carica amministrativa, dal momento che la normativa della s.r.l. si limita a disciplinare ex art. 2476, 3° comma, c.c. il potere del singolo socio di chiedere la revoca giudiziale al tribunale per gravi irregolarità e non detta espressamente alcuna altra disposizione [[64]] relativa appunto alla revoca da parte della collettività dei soci. Tale mancanza [[65]] si comprende se rapportata alla specificità della normativa della s.r.l. in ordine alla nomina degli amministratori e alla durata della carica: normativa che, infatti, fissa come regola di default la competenza all’attribuzione dell’incarico e alla fissazione della sua durata in capo alla pluralità dei soci, e riconosce agli stessi il potere di derogare a tale regola nei limiti innanzi indicati; cosi che si spiega come non possa operare una disciplina unitaria in tema di revoca, ma verrà ad applicarsi la regola più conforme al modello legale, o a quello derogatorio fissato statutariamente dai soci stessi [[66]]. Da questa considerazioni si traggono una serie di spunti che servono a precisare gli aspetti qualificanti la disciplina della revoca, relativi al quando, al quomododebba esercitarsi il potere di revoca [[67]], e ai soggetti titolari di tale potere. Invero in presenza del modello legale, quindi di nomina esclusiva da parte dei soci, per individuare le ipotesi di revoca, le modalità della stessa e i soggetti legittimati il riferimento è da farsi alle regole dettate in tema di società di capitali, in quanto la s.r.l. va ricondotta a questa struttura tipologica. Le regole a cui riferirsi, peraltro, si distinguono a seconda della modalità adottata relativa alla durata della carica amministrativa: infatti in caso di nomina a tempo determinato e conseguente previsione del reclutamento ciclico degli amministratori, non può non applicarsi la disciplina della società per azioni dettata al 3° comma dell’art. 2383 c.c. [[68]]; disciplina che riconosce come soggetti legittimati all’esercizio della revoca la collettività dei soci e non solo, ma stabilisce che la decisione (di revoca) deve [continua ..]
Problemi differenti sorgono in ordine all’individuazione della disciplina in tema di revoca nelle ipotesi in cui con previsione statuaria, in forza dell’art. 2468, 3° comma, c.c., sia stato attribuito ad uno o più soci il diritto di amministrare, o il diritto di nominare uno o più amministratori [[77]]. Le due ipotesi vanno esaminate separatamente, perche valgono considerazioni diverse. Nell’ipotesi in cui sia riconosciuto in capo al socio il diritto ad amministrare, la carica gestoria inerisce (alla) e qualifica la posizione di socio nel senso che la prima è elemento contenutistico della seconda; ed infatti per la modificabilità del diritto “amministrativo” è fissata nel 4° comma dell’art. 2468 c.c. la regola del consenso unanime [[78]], regola che esplicita come il diritto “amministrativo” connoti la partecipazione sociale a cui si ricollega, in quanto il primo potrà essere variato o addirittura eliminato con il consenso del titolare della seconda [[79]]. Va sottolineato che la revoca è potere che spetta agli altri soci e ciò significa che la decisione relativa è assunta dagli altri soci con esclusione del socio amministratore da revocare e quindi tipicamente non con il consenso espresso da tutti i soci; di conseguenza tale decisione non può ricondursi tout court alla fattispecie regolata dall’art. 2468, 4° comma, c.c. [[80]]. Da ciò si trarrebbe, secondo un’opinione, rimasta peraltro isolata, che si dovrebbe negare in ogni caso la revocabilità da parte degli altri soci dalla carica gestoria attribuita come diritto particolare [[81]], in quanto nella disciplina della s.r.l. non potrebbe operare regola diversa da quella dettata nell’art. 2468, 4° comma. Opinione questa non condivisibile, perché si avrebbe un ipotesi di irrevocabilità assoluta che costituirebbe un eccezione all’interno dell’ordinamento non giustificata, dal momento che vige il principio generale della libera revocabilità dell’incarico e v. art. 1725 c.c. (principio quindi che opera anche in tema di società come innanzi precisato); ed è prevista come deroga unicamente l’ipotesi di inefficacia della revoca in assenza di giusta causa (ipotesi qualificata come irrevocabilità c.d. reale) e cosi l’art. 1723, 2° [continua ..]