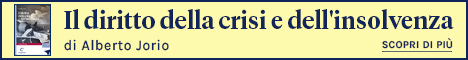
«Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi».
Sperando di non scomodare inutilmente certa Letteratura, ritengo che tale celebre asserzione possa, in realtà, ben rappresentare l’attuale stato del diritto societario. Sulla scorta della suesposta voluta provocazione, il presente lavoro mira ad indagare il fenomeno delle società benefit quale ulteriore apporto al processo di ibridazione che il diritto delle società sta attualmente conoscendo.
Il processo di ibridazione (secondo alcuni di “neutralizzazione”) del “tipo” societario affonda le proprie radici non solo nella già (ad esempio) risalente normativa delle società per azioni (senza scopo di lucro) gestrici dei mercati regolamentati, ma anche nel diritto societario più moderno (si vedano le start-up innovative) e “sportivo”, come testimoniato dalla recente riforma della disciplina delle società sportive, con cui si era concessa cittadinanza giuridica alle società sportive dilettantistiche lucrative, le quali però, poi, con una repentina controriforma (Decreto Dignità), sono state abrogate.
Tuttavia, in queste pagine non si intende condurre un pletorico studio del profluvio normativo che negli ultimi tempi ha (s)convolto il diritto societario (si pensi altresì all’introduzione delle imprese sociali lucrative), in quanto un’indagine così condotta rischierebbe di risultare pleonastica, poiché il soffermarsi su ogni esternazione di diritto positivo, frutto del richiamato afflato riformista, si tradurrebbe nella produzione di un lavoro del tutto inane, dal momento che, ad oggi, il grado di ibridazione (o neutralizzazione) del diritto societario non necessità di ulteriori dimostrazioni.
In quest’ottica, partendo dalla disamina delle società benefit quale nuova forma di ibridazione dei modelli di impresa, il presente saggio cercherà di mettere a fuoco i profili di responsabilità degli amministratori di tali società, visto che saranno poi questi ultimi a rispondere di un’eventuale decozione della società, tanto sul piano economico quanto su quello sociale, causando così una responsabilità che si potrebbe definire anch’essa come ibrida.
«If we want things to stay as they are, things will have to change».
Without pointlessly bringing up, I hope, certain Literature, I believe that such well-known statement could actually represent at its best the present state of corporate law. Based on the above-quoted deliberate provocation, this article explores the phenomenon of Benefit corporations as a farther contribution to the process of hybridization (or “neutralization”, as also defined by others) that corporate law is experiencing at present.
Such a process of the corporate “type” is rooted non only (say) in the former regulations of limited companies (non-profit), but also in the more modern corporate law (e.g., innovative start-ups) and sports regulation, as testified by the recent reformation of the discipline of sports companies, which gave legal citizenship to non-professional profit-making sports associations, then quickly repealed by the counter-reformation of the “Decreto Dignità”.
This article, however, does not address the regulatory riot which has lately upset corporate law. Such an attempt would be, to say the least, pleonastic. To highlight any outpouring of positive law, a consequence of the above-mentioned reformist spirit, would hardly be meaningful, inasmuch as the degree of hybridization (or neutralization) of corporate law needs, at present, no illustration or further evidence.
From such a standpoint, starting with a discussion of Benefit corporations as a new form of hybridization of enterprise models, the essay focuses on the different facets of responsibility of the corporation managers, being these figures accountable for any potential insolvency of the corporation at both a financial and a social level, thus implying a kind of responsibility which, in turn, could be just as well defined as hybrid.
Keywords: benefit corporations – hybridization of enterprise models – stakeholders.
1. Le società benefit e la corporate social responsibility - 2. La legislazione italiana in tema di società benefit - 3. L’amministrazione delle società benefit. Tra molteplici responsabilità e interessi - 4. Note conclusive - NOTE
Prima di procedere alla trattazione delle benefit corporation o società benefit (di seguito: SB) [[1]] è doveroso richiamare alcune delle recenti riflessioni dottrinali maturate in ordine alla c.d. corporate social responsibility. In quest’ottica, pur sottolineando la mancanza di una definizione unanime della corporate social responsibility (di seguito: CSR) [[2]], certa dottrina accredita quest’ultima come un «sistema di valori» capace di qualificare l’operato dell’impresa, responsabilizzando “eticamente” il governo societario di questa ultima, rafforzandone quindi la credibilità nel mercato (sia dinnanzi ai consumatori che agli investitori) [[3]]. In alternativa, diversa dottrina vede nella CSR «un modello di gestione allargata» finalizzato al bilanciamento di più e diversi interessi contrapposti, e cioè dunque un «sistema complesso di normative che regolano i diversi aspetti di quelle attività di impresa che incidono sull’assetto della società umana» [[4]]. Nondimeno, altra dottrina milita per una differente definizione di CSR, e a tal riguardo ha ribadito che l’elemento caratterizzante di tale responsabilità sociale sarebbe quello dell’integrazione su base volontaria dei problemi sociali nelle dinamiche imprenditoriali. Non sorprende quindi che per tale dottrina la CSR debba contemplare «l’eventualità che si operi per finalità diverse da quelle indicate dai soci e che ciò non avvenga in ottemperanza a doveri giuridici o morali, [ma] avvenga cioè volontariamente» [[5]]. Per debito di precisione, giova rammentare che all’orientamento appena citato se ne contrappone un altro, che diversamente accoglie con favore le eventuali innovazioni legislative tese a rafforzare e attuare i principi della CSR [[6]], la quale, infatti, avrà tanta più solidità quanto più sarà scortata da norme giuridiche (come potrebbero essere la disciplina SB o la normativa sulle dichiarazioni non finanziarie [[7]], cioè il c.d. “bilancio sociale”) [[8]] o di incentivazione fiscale, e quindi non semplicemente affidata alla mera volontarietà, così come vorrebbe quella dottrina che difende, forse eccessivamente, l’aspetto volontaristico. Pur essendo simpatetico con [continua ..]
Individuata la cornice, più o meno definita, entro cui le SB si collocano, si può ora trattare, fugacemente, la disciplina delle stesse. La SB è stata introdotta dalla legge di stabilità, 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: “legge SB”) dal 376° comma al 382° comma, la quale, pur imitando il modello legislativo statunitense [[45]], è stata la prima normativa europea sulle SB, tantoché parte della dottrina ha rivisto nel predetto primato normativo un altro “primo posto” tutto italiano, come quello – più risalente – relativo alla disciplina delle società cooperative sociali [[46]]. Nondimeno, tralasciando tale poco interessante “primato” temporale, ciò che invece merita di essere evidenziato, sul piano squisitamente sistematico-normativo, è il fatto che la disciplina delle SB sia stata “innestata” tra i ben 999 commi di una legge di stabilità [[47]]. In particolare, la (infelice) scelta del Legislatore di dedicare alle SB un apparato normativo composto da appena nove commi (dal 376° al 384°) della legge di stabilità de qua è prova sia di un oramai pessimo modus legiferandi del Legislatore nostrano, sia della scarsa intelligibilità che la stessa disciplina delle SB si troverà a scontare per via della sua normativa disarmonica rispetto al vigente Codice civile, disarmonia che, come si dirà in seguito, ha generato alcune incertezze giuridiche. La legge SB al 376° comma qualifica le SB come le società che: «nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di divider(ne) gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi» [[48]]. In modo consequenziale il 377° comma della legge SB prevede che: «Le finalità di cui al 376° comma sono indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da [continua ..]
Esaurita tale breve premessa inerente ai tratti salienti delle SB, sembra opportuno soffermarsi su uno degli aspetti più controversi dell’intera disciplina in esame, e cioè quello riguardante l’amministrazione delle società de qua. In particolare, si farà riferimento esclusivamente a quelle problematiche che possono insorgere in ordine alla dualità di interessi e scopi coinvolti nelle SB [[64]]. La predetta dualità di interessi e scopi è ben rappresentata dal 380° comma della legge in esame, il quale dispone: «La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel 376° comma, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal Codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità». E consecutivamente, il 381° statuisce che: «L’inosservanza degli obblighi di cui al 380° comma può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal Codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori». Sulla scorta di tale impianto normativo, è spontaneo domandarsi se sia esperibile o meno l’azione di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo che, pur avendo disatteso gli obiettivi prefissati relativamente all’attività di beneficio comune, abbia però incrementato la perfomance economica della SB facendo conseguire alla stessa risultati economici apprezzabili. Tale primo interrogativo non si presta ad una semplice risoluzione. In particolare, pur sorvolando sul problema della pressoché quasi impossibile quantificazione del danno (quale presupposto sostanziale dell’azione di responsabilità) [[65]], la normativa delle SB, richiamando espressamente la disciplina vigente del Codice civile in materia societaria, sembrerebbe legittimare l’esercizio di un’azione di responsabilità solamente nei confronti di quegli [continua ..]
Come inizialmente scritto, pur non volendo assumere posizioni manichee, si ha l’impressione che la legge SB, nata pur con l’intento di cambiare “qualcosa” dell’attuale assetto del diritto societario, alla fine si sia tradotta in una iniziativa del tutto inane, o quasi (magari, come ricordato da attenta dottrina, si intendeva solo coonestare il rafforzamento dell’industria delle certificazioni) [[87]]. Tale considerazione è suffragata dal fatto che la SB, in realtà, non è altro che un corpo poco luminoso immerso in una grande costellazione già fitta di molteplici astri (si pensi alle imprese sociali, cooperative sociali, società sportive dilettantistiche, start-up a vocazione sociale) mossi da quella forza centrifuga che sta svuotando dell’identità causale l’archetipo societario di cui all’art. 2247 [[88]], con la differenza che i citati istituti – al contrario delle SB – hanno dimostrato di aver avuto, nel nostro ordinamento, un impatto significativo sia a livello economico che giuridico, oltreché una struttura normativa più nitida, rispetto alla disciplina delle SB, in ordine ai limiti alla distribuibilità ai soci di utili e riserve, come pure ai limiti alla devoluzione ai soci del patrimonio della società al momento dello scioglimento della stessa [[89]]. Per debito di precisione e a supporto di quanto suesposto, è sufficiente rammentare che il legislatore nella disciplina SB non instaura alcuna graduazione tra scopo di lucro e beneficio comune (in altre parole non c’è uno scopo prevalente), diversamente da quanto si evince dalla disciplina delle imprese sociali e delle società cooperative, ove lo scopo di lucro (soggettivo) non rappresenta il fine principale dei soci, bensì questo ultimo risulta essere subordinato, rispettivamente, alle «finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale» (art. 2, d.lgs. n. 112/2017) e allo scopo mutualistico (art. 2511 c.c.) [[90]]. In sintesi, non v’è chi non veda in questa causalità ibrida, o meglio opacità di scopi, delle SB un rischio di incertezza gestoria a danno dei soci e del management, e un rischio di confusione nel mercato ove le SB potrebbero essere percepite al pari delle imprese sociali o delle società cooperative (quando invero non lo sono affatto), il [continua ..]